ciao
- Visite: 7
ciao
La storia dell'arte è la disciplina teorica e storica che studia la nascita e il progresso delle espressioni artistiche, attraverso un punto di vista metodologico filosofico ed estetico oltre che semiotico, cognitivo e letterario, con particolare riguardo ai fenomeni distintivi. Nell'arco dei secoli si è formalizzata come ricerca di conoscenze, tecniche e descrizioni, utili alla comprensione delle più varie forme artistiche. Le prime descrizioni autentiche compaiono in testi greci antichi (Pausania) e romani (Plinio il Vecchio).
In quanto disciplina teorica si occupa dei principi estetici e storici della funzione estetica, della costituzione e delle variazioni di forme, degli stili e dei concetti trasmessi attraverso opere d'arte. Una grande divisione, tra arte e tecnica, nasce nell'Accademia platonica, a contrasto delle forme ibride di imitazione. Nel corso delle importanti egemonie culturali, il punto di vista dello storico dell'arte, è stato omologato alla ricerca e diffusione di canoni operativi. Nella sua veste di ricerca stilistica e biografica, essa adotta i criteri della filosofia e della storia letteraria, così come della psicologia evolutiva e della critica d'arte.
Solo dopo la metà dell'Ottocento, l'interesse della sociologia, per studi psicologici e letterari, ha comportato un orientamento verso la comprensione del fenomeno artistico dal punto di vista dei fenomeni sociali coinvolti. In questo quadro scientifico di studi contemporanei, è stato possibile completare la ricerca da un punto di vista sociopedagogico e psicopedagogico, con teorie sulla "formatività" (Pareyson) e sull'apporto dei musei, delle gallerie e degli archivi pubblici e privati, messi in luce dalla critica contemporanea.
La storia dell'arte è intesa anche come rispetto delle sistematicità che essa contiene e contribuisce a far conoscere, mediando tra conservazione, innovazione culturale e industriale. Opere unitarie sulla personalità artistica ottengono l'ambito riconoscimento di ricomporre la teoria e la tecnica delle arti. Si pensi al saggio di Benvenuto Cellini. Uno dei successivi maggiori contributi, nasce con l'esperienza vivida dei manieristi al seguito di Michelangelo Buonarroti: Giorgio Vasari comprese la necessità di raccogliere le testimonianze letterarie e critiche, concrete e collezionistiche, tecniche e diaristiche proprie degli artisti e quindi raccolse utili informazioni allo scopo di tracciare la fortuna delle opere e degli artisti.
Facendo così intese riportare la tradizione culturale italiana a partire da Giotto, costituendo un modello, presumibilmente derivato dall'arte greca, della maniera, affrancandola dall'ambito servile in cui era collocata per essere considerata un'arte libera alla pari con il lavoro intellettuale. La sua raccolta, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, permette di riconoscere la continuità dello stile e la necessità critica di un giudizio sull'arte e sull'architettura, ha innovato nello stile, ha dato un'impronta negli studi, almeno fino a Federico Zeri. La funzione di queste raccolte, pubblicate a mezzo stampa, ebbe colorazioni diverse. Marco Boschini, scriverà con un lessico veneziano, il modo di interpretare la pittura, in una Venezia aperta al riconoscimento e al mercato internazionale, non di meno con intenzioni allegoriche e istruttive dal punto di vista culturale e morale.
In Italia, si sono percorse influenze profonde, ancorate a principi teorici: dalla storia della religione, all'evoluzione dei concilii, dalla manifestazione di opere pubbliche alla realizzazione di scuole, motivo per cui, una storia dell'arte, può avere come suo ancoramento intrinseco, una vocazione dal tratto antropologico culturale propria. Il metodo dello storico dell'arte, in sintesi, deve potersi avvicinare a quello del sociologo e semiotico visivo pur rappresentando conoscenze evolutive proprie e accostandosi al metodo filosofico e naturalistico delle scienze. In quanto disciplina, deve occuparsi di tutte le forme artistiche, potersi specializzare e ricoprire quindi una veste scientifica propria per poter essere trasmessa.
L'aspetto approfondito del bene culturale, così come le conoscenze di opere e di autori, in particolare in pittura, in scultura e in architettura, sono il fondamento degli studi accademici, specialistici e di ricerca. Inoltre, come ogni altra disciplina storica e umanistica, la storia dell'arte è soggetta ad un'opera di interpretazione e riconoscimento critico ed è soggetta al metodo storiografico progressivo.
Lo studio dei contesti, degli antefatti, delle condizioni ambientali e dei mutamenti, della collocazione e della condizione della conservazione, in cui un'opera è stata concepita, realizzata, recepita e studiata, nonché della committenza e dei materiali, è parte integrante sia per la comprensione del significato, delle funzioni tipiche dell'opera, sia del percorso artistico e del valore dell'opera.
A queste competenze si aggiungono la museografia e il restauro del bene culturale. Anche su questo piano, la storia dell'arte, deve poter cercare le analogie e le differenze comprese nell'opera, dal punto di vista dei legami con altre scienze, degli usi e dei costumi, nell'impegno complessivo di partecipare allo sviluppo democratico e alla conoscenza in genere.
La "descrizione analitica" (ékphrasis) del formarsi delle opere d'arte, e delle opere stesse, permette di affrontare tematiche di vasta portata: i ricettari, i trattati, i dizionari monografici, del disegno e del colore, sia tecnici che a glosse, favoriscono la divulgazione della storia delle arti, e rendono possibile una competenza settoriale, uno studio distintivo in Arti maggiori e Arti minori nel rispetto del ritrovamento. Con il contributo dell'archeologia, le opere d'arte possono essere studiate e descritte approfondendo aspetti ragionati che la costituiscono: dalle osservazioni presemiotiche e meno intenzionali, dai materiali alla conoscenza strutturata, dobbiamo il formarsi di settori propri: iconologia, iconografia, allegoria e simbolo, che di volta in volta hanno arricchito la letteratura artistica, favorendo il nascere di correnti di pensiero (ut pictura poïesis).
Lo studio delle opere del passato, soprattutto se appartenenti a culture distanti, porta, in particolar modo, alla conoscenza e al rispetto di codici culturali e filosofici ai quali le opere fanno riferimento. Lo studio articolato delle invenzioni e delle scoperte, in storia e storia dell'arte, porterebbe ai significati teorici stessi delle opere d'arte ritenute maggiori.
L'arte, afferma Edgar Wind, è sottoposta a principi regolativi universali, educare con l'arte, significa concedere all'espressione e al contenuto artistici, uno statuto normativo e progettuale proprio, che attinge alla forma stessa dei linguaggi dei primordi che hanno permesso la formazione del gusto, dell'estetica e dell'etica nelle varie epoche. I contributi degli storici dell'arte, non possono che provenire da spontanee costruzioni professionali, nozioni, competenze, disposizioni che restituite ne favoriscono l'accesso, tuttavia nel corso del Novecento sono nati veri e propri istituti di eccellenza. Ad esempio il Warburg Institute di Londra, si è occupato dell'orientamento religioso, allegorico e astrologico delle opere d'arte.
Con la didattica museale si esprime un concetto affine, quello del significato dell'esperienza diretta del fare artistico accanto alla fruizione estetica del sapere, si favorisce la conoscenza individuale del valore estetico dell'opera d'arte. Le correnti strutturaliste e costruttiviste, linguistiche e psicologiche, hanno orientato la pedagogia artistica sulle direzioni di senso, legate alla comprensione delle procedure artistiche tecniche.
Nel 1842 Franz Theodor Kugler scrisse il primo libro sulla storia dell'arte[1] al quale si deve la partizione della storia dell'arte in quattro momenti (preellenico o dei popoli primitivi, classico o dell'antichità greca e romana, "romantico" o dell'arte medievale e islamica, moderno dal rinascimento al XIX secolo), seguito nel 1855 dal diffusissimo manuale di Anton Heinrich Springer.[2]

È complicato tracciare un preciso quadro storico sulle origini dell'arte: essa risale, infatti, alle primitive figurazioni delle popolazioni che iniziarono a riporre nella rappresentazione simbolica una concettualità artistica probabilmente, all'inizio, con intenti didascalico-narrativi o, più verosimilmente, unicamente propiziatori.
Nel Paleolitico superiore si sviluppò l'usanza di ritrarre, tramite graffiti o dipinti, immagini legate alla vita quotidiana, prevalentemente scene di caccia ma anche momenti legati all'agricoltura e all'esperienza religiosa. Il supporto era costituito dalle rocce degli interni delle grotte: grazie alla protezione dagli agenti atmosferici, molte di queste pitture (dette per l'appunto rupestri) sono giunte fino a noi.
In caso di esecuzione di graffiti, si utilizzavano rudimentali strumenti (prevalentemente in pietra), mentre per le pitture si mescolavano terre utilizzando come leganti sangue, grasso e altre sostanze, successivamente stese con l'ausilio delle mani, di bastoni o di peli di animali.
L'arte preistorica, per la sua figurazione essenziale e incisiva è stata fonte di ispirazione per molti artisti moderni, fra i quali Pablo Picasso, per alcuni aspetti quale apporto interculturale.
Per ragioni probabilmente da ricondursi ad un più antico e profondo sviluppo dello stesso concetto di arte, oltre che ad una numericamente più copiosa produzione, la storia dell'arte sino a tempi recenti si è occupata in prevalenza delle aree culturali del bacino del Mediterraneo, sul quale si affacciano le regioni dell'arte classica e rinascimentale.
Con il sorgere del secondo millennio, allo studio dell'arte greca e di quella romana, di quella bizantina e di quella prodotta nell'area italiana e provenzale, si è estesa la considerazione alle produzioni delle aree dei Franchi e dei Sassoni, includendo quindi progressivamente porzioni sempre più estese di fonti del Vecchio Continente, di pari passo con lo sviluppo delle comunicazioni culturali fra gli stati europei, che consentivano di prendere scambievole nozione, ad esempio del contributo romanico e di quello gotico.
Il succedersi dell'Umanesimo e del Rinascimento italiano, seguiti dalla renaissance francese, riportò sulla penisola italiana e sul paese confinante il fuoco dell'attenzione. È questo, del resto, il periodo in cui la produzione artistica esplose di rigogliosa fioritura particolarmente nei campi della pittura, della scultura e dell'architettura, ed è dunque la fase in cui divenne parimenti necessario uno sviluppo organico dello studio, anche in ragione, non va nascosto, del crescente valore economico delle opere di quei campi.
In più, mutate condizioni culturali favorirono lo sviluppo di una sorta di ceto artistico, forse non organizzato in corporazione, ma comunque di sempre più solida importanza sociale, caratterizzato da un verso dalla pluralità di modi espressivi di ciascun autore (spesso capace, cioè, di dipingere come di scolpire, o di usare altre forme artistiche) e da un altro verso da una sempre più intensa comunicazione fra gli autori che, nella sfida competitiva come nella prova istrionica, davano prova costante di conoscenza tecnica e logica delle opere dei colleghi (e quindi compivano un vero e proprio studio dell'arte altrui). Il più noto fra coloro che si posero con consapevolezza scientifica dinanzi alla produzione dei colleghi fu certamente Giorgio Vasari, che con la sua opera Vite degli Artisti, malgrado l'assenza del mero tentativo di evitare giudizi personalistici, introduce peraltro un canone (si potrebbe forse dire un canone artistico) nello studio storico che si riflette tuttora nello svolgimento dei temi di questa disciplina.
Se nel Seicento entrarono a far parte dello studio le "barocche forme del barocco" (intendendosi, con questa nota locuzione, l'innumerevole e ridondante quantità di differenziazioni produttive nei sempre più numerosi paesi in cui fu sviluppata), e mentre si consolidava l'importanza della produzione dei paesi dell'Europa settentrionale, con il riconoscimento dell'importanza dell'area fiamminga, il lussuoso Settecento aprì a nuove aree di studio, incrementate peraltro dallo sviluppo della musica e delle arti letterarie e teatrali.
Lo studio ottocentesco si giovò dei progressi tecnici (anche delle altre scienze, ad esempio dell'archeologia) per approfondire l'indagine e di un diffuso crescente sentore di "necessità d'arte" per imporre l'importanza delle proprie elaborazioni, nel secolo che avrebbe celebrato la consacrazione delle "Belle Arti".
Il Novecento, con gli straordinari sviluppi delle modalità di comunicazione, ma anche (e forse per effetto di quelli) con la sua crescente progressione di approfondimento culturale, di pari passo seguita dall'espansione fra le classi sociali della frequentazione dell'arte (e con la diffusione dell'arte popolare), creò le condizioni per una venuta a maturità della storia dell'arte, che oggi ricerca con indirizzo più strettamente scientifico di ristrutturare le proprie metodologie.
La storia dell'arte, contrariamente ad una tradizione peraltro più avvertita presso le culture anglosassoni che non presso quelle latine, non si limita (o forse non si limita più) all'indagine sulle arti figurative (e visive in genere), nonostante soprattutto in relazione ai secoli passati tale specialità costituisca una porzione ben rilevante dell'intera sua analisi.
Sempre labile si è rivelata la linea di confine fra il relato storico ed il commento critico, e ben più che per la storia, si segnala per questa disciplina invece un costante conflitto fra l'esigenza di una narrazione oggettiva e neutrale, come nel metodo scientifico tradizionale, e la difficoltà di rendere l'elaborazione e l'analisi senza far trapelare un convincimento dello studioso (artistico, filosofico, religioso, etico) che inevitabilmente finisce col costituire interpretazione e dunque si pone a rischio di partigianeria, comunque motivata.
Nel tempo, quindi, la critica ha assunto un ruolo di cospicua infiltrazione (con la relativa influenza) nella narrazione storica, determinando, a detta di alcuni, i successi o l'oblio di talune opere e di taluni artisti; la circostanza ha una sua rilevanza non irrisoria dato il necessario riferimento materiale al finanziamento dell'arte, che abbisogna infatti quasi sempre (con poche eccezioni) di una disponibilità finanziaria di terzi (anche successivamente alla realizzazione dell'opera, in stretti termini di "vendibilità commerciale" della stessa) per potersi alimentare. La determinazione delle provvidenze per l'arte (mecenatismo) è infatti spesso storicamente dipesa dalle analisi degli storici dell'arte, assunti (taluno dice, assoldati) dai munifici "sponsor" che desiderano finanziare l'arte (ed investire in arte), pur non disponendo di capacità critiche personali.
Nell'area compresa tra l'odierna Turchia e la foce dei due fiumi Tigri ed Eufrate, allora chiamata Mesopotamia, circa 5000 anni fa, i primi agricoltori impararono a governare le piene dei fiumi e a sfruttare la fertilità del suolo. Lo sviluppo economico che ne seguì permise la formazione delle più antiche città della storia. Il popolo dei Sumeri fu il primo a insediarsi in Mesopotamia attorno al 4500 a.C.; è a loro che dobbiamo progressi tecnologici quali l'uso della ruota e l'invenzione della scrittura. Successivamente altre popolazioni si stabilirono in quest'area: nel 2000 a.C. gli Assiri, un popolo guerriero e molto combattivo e nel 1800 a.C. i Babilonesi, così chiamati dal nome della mitica città di Babilonia. Le città, anche se costruite in epoche diverse, avevano caratteristiche comuni: erano circondate da mura o fossati e possedevano all'interno un grande tempio, detto ziqqurat, realizzato con mattoni di argilla essiccati al sole. Sulla sommità di questi imponenti edifici si riteneva abitassero le divinità, a cui i sacerdoti e fedeli si rivolgevano con preghiere e offerte.

Nell'antico Egitto l'arte era uno strumento al servizio della politica e della religione. Essa rifletteva l'immutabilità del potere del faraone, il suo essere divinità vivente che continua a esistere nell'immagine dipinta o scolpita anche dopo la morte. Nella statuaria gli dèi, il faraone, i dignitari di corte furono rappresentati sempre in pose stilizzate, con lineamenti idealizzati che non conoscono i segni della vecchiaia o della malattia. Nella postura in piedi, hanno le braccia lungo i fianchi e muovono un passo in avanti come se camminassero lentamente; se vengono ritratti seduti appoggiano le mani sulle ginocchia. Tutto era previsto dal rigido cerimoniale di corte e agli artisti non rimaneva che seguire delle precise regole di rappresentazione. L'unica eccezione riguardò il regno di Amenofi IV (poi conosciuto come Akhenaton): questo faraone promosse la massima rivoluzione religiosa della storia d'Egitto e durante il suo regno agli artisti venne concessa una maggiore libertà interpretativa, come testimonia il busto-ritratto della regina Nefertiti, sua moglie.

Le prime póleis greche nacquero a partire dall'VIII secolo a.C. La rapida crescita della popolazione e la scarsità delle risorse spinsero i Greci a esportare questo modello di organizzazione anche nelle colonie, che fondarono un po' in tutto il Mediterraneo. Al centro della pólis, circondate da case e botteghe, si trovava l'agorà, la piazza del mercato e delle pubbliche assemblee; la parte più alta della città costituiva l'acropoli. La più celebre acropoli della Grecia è quella di Atene. L'acropoli era l'area sacra, dove sorgevano i templi in onore delle divinità e si celebravano le feste Panatenee, con solenni processioni religiose e manifestazioni sportive. Con il governo di Pericle, l'artefice della democrazia ateniese, e sotto la supervisione dello scultore Fidia, la rocca di Atene si trasformò in un frenetico cantiere dove affluivano gli ingegni e gli artisti migliori del tempo. Si costruirono il Partenone, tempio così chiamato da Athena Parthénos, la dea protettrice della città; i Propilei, cioè l'ingresso monumentale all'area sacra; il Tempio di Atena Nike, di piccole dimensioni ma di squisita eleganza; l'Eretteo, un tempio costituito da diversi ambienti tra cui la celebre Loggia delle Cariatidi, dove le colonne sono sostituite da eleganti figure femminili.
Per i Greci il tempio doveva esprimere un'idea di bellezza e armonia tra le parti, per questo alla sua costruzione partecipavano i più abili architetti del tempo. Presso il cantiere, le maestranze prima sbozzavano i blocchi facendo assumere loro la forma desiderata, poi servendosi di funi e carrucole, li collocavano nel punto stabilito dall'architetto. L'esterno del tempio veniva successivamente decorato da rilievi e da sculture, a volte dipinte con colori vivaci; i rilievi ornavano sia il frontone sia il fregio. Il tempio più ammirato dell'acropoli di Atene fu sicuramente il Partenone. Ciò che rendeva questo edificio il caposaldo dell'arte greca era soprattutto la ricchezza delle sue decorazioni, superiori a qualsiasi edificio mai costruito. L'artista chiamato a dirigere questo immenso cantiere fu lo scultore Fidia, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.
Il tempio rappresentava per i Greci la costruzione più perfetta e armoniosa. Per raggiungere questa perfezione gli architetti si servivano di regole geometriche e matematiche con cui legare ogni dettaglio dell'edificio. Questi diversi modi di concepire la costruzione di un tempio sono stati chiamati «ordini». Gli ordini utilizzati dai Greci sono tre:

Si caratterizza per l'essenzialità e la solennità delle sue forme. La colonna dorica non ha una base, poggia direttamente sullo stilòbate (il pavimento del tempio), è rastremata verso l’alto (si restringe verso l'alto) ed è solcata da 20 scanalature a spigolo vivo. A 3/4 della colonna è presente l’entasi, un lieve rigonfiamento che serviva per correggere l’effetto ottico che rendeva le colonne concave se viste da lontano. Il capitello ha una forma semplice (formata da echino e abaco) che serve a sostenere i blocchi di pietra rettangolare che formano l'architrave. La decorazione del fregio è costituita da lastre scolpite dette mètope alternate da pannelli solcati da tre scanalature detti triglìfi.

Si caratterizza per una maggiore eleganza e leggerezza rispetto a quello dorico. La colonna non poggia direttamente sullo stilòbate, ma ha una propria base costituita da toro (sporgenza), scozia (rientranza), toro. Le scalanature sono 24 e a spigolo smussato. Il capitello è decorato da òvoli (così chiamati per la forma che ricorda delle mezze uova) e da due eleganti volute che si piegano lateralmente. Nella trabeazione, il fregio è continuo: sono assenti metope e triglifi.

L'ordine corinzio (l’ultimo dei tre ordini) fu impiegato soprattutto per l'interno dei templi. Il fusto della colonna corinzia è uguale a quello dell’ordine ionico con l’aggiunta del plinto sotto la base della colonna. Il capitello è formato da due corone di foglie di acanto ed è la parte che caratterizza maggiormente l’ordine corinzio.
Gli artisti della Grecia antica cercarono di produrre delle opere ideali, in grado di non sfigurare al cospetto delle divinità. Questo risultato fu raggiunto, specialmente nella scultura a tutto tondo, attraverso un lungo e ininterrotto processo di perfezionamento formale. Le prime testimonianze appartengono all'età arcaica, tra il VII e il VI secolo a.C.: si tratta di giovani nudi o di fanciulle vestite caratterizzati dalla fissità dell'espressione.
Durante l'età classica (V-IV secolo a.C.), uno studio più attento del movimento e dell'anatomia umana permise agli scultori di raggiungere traguardi di sorprendente bellezza e armonia. I Greci idealizzavano la bellezza fisica, a cui doveva sempre rispondere la bellezza interiore: l'una doveva essere lo specchio dell'altra. Le opere di Policleto, di Mirone e di Prassitele testimoniano lo straordinario livello raggiunto nella ricerca delle proporzioni. Bisogna tuttavia ricordare che nessuna di queste statue è da intendersi come il ritratto di persone realmente esistite: sono piuttosto la rappresentazione delle qualità fisiche e morali del genere umano e, proprio perché distaccate dalla realtà terrena, si collocano in una sfera di ideale perfezione.
Durante questa stagione Greci e non Greci furono protagonisti di una storia e di una cultura universali capace di mettere in contatto tra loro mondi e tradizioni diverse. Con l'Ellenismo la Grecia non rappresentò più l'unico centro d'influenza del mondo antico: la Macedonia, le città di Pergamo in Asia Minore, di Antiochia in Medio Oriente e di Alessandria d'Egitto divennero centri politici, culturali e artistici altrettanto importanti. Questi cambiamenti portarono molte novità nelle arti. Nella costruzione degli edifici, gli architetti cercarono di esaltare la spettacolarità, la monumentalità e la scenografia. Le città ellenistiche, racchiuse da solide mura, divennero simili ad immensi teatri. Colossali sculture, poderosi colonnati e scalinate imponenti avevano lo scopo di intimorire i sudditi e di glorificare la potenza dei tiranni, che in epoca ellenistica avevano sostituito i regimi democratici. Gli artisti al loro servizio, abbandonati gli ideali astratti della bellezza, presero in considerazione aspetti prima trascurati. Le ricerche dei pittori e degli scultori mutarono e si diversificarono: essi rappresentarono con realismo espressioni di dolore, crudeltà e sofferenza fisica; si presero gioco dei difetti umani raffigurando persone afflitte dalla vecchiaia o dalla deformità; impararono a interpretare in modo più esplicito la seducente bellezza del corpo femminile.

L'arte etrusca si espresse ad alto livello nella lavorazione dei metalli, nella ceramica e nella pittura, raggiungendo risultati di rilievo; poiché la pittura greca è andata perduta, quella etrusca rappresenta la più importante testimonianza di epoca pre-romana. Gli Etruschi rivelarono la loro abilità soprattutto nella costruzione di edifici civili e religiosi, adottando l'arco a volta semicircolare. A loro si deve la costruzione di città fortificate con possenti mura in pietra e dotate di porte, quali Perugia, Arezzo, Volterra. Purtroppo la deperibilità dei materiali e il fatto che le città etrusche siano state espugnate, riedificate nei secoli successivi e abitate fino ai nostri giorni, hanno causato la perdita pressoché totale delle realizzazioni di quella civiltà.
L'evoluzione dell'arte romana avvenne gradualmente, sotto l'influenza della pittura greca ed etrusca. In genere si trattava di una pittura veloce, stesa con rapidi tocchi di colore, e tuttavia capace di sorprendenti effetti tridimensionali. Andata perduta quasi del tutto la pittura su tavola, si è salvato un consistente numero di affreschi, notevole soprattutto a Pompei e a Ercolano, destinati a ornare grandi edifici pubblici e lussuosi ambienti domestici. Si è anche conservato un notevole numero di mosaici, spesso utilizzati in alternativa alla pittura per decorare pareti e pavimenti. I maestri mosaicisti, impiegando tessere molto piccole, riuscivano infatti a produrre effetti cromatici simili alla pittura. I temi variano da motivi geometrici a soggetti tratti dalla natura a riproduzioni di giochi, battaglie o scene di caccia.

Nel III secolo, nonostante le persecuzioni, il Cristianesimo era già diventato una religione abbastanza diffusa. Gli esempi di arte paleocristiana (dagli inizi, fino al sec. VI circa), risalenti a questo periodo sono piuttosto scarsi e di quantità modesta. Per le tombe i primi cristiani sceglievano dei cimiteri comunitari assai semplici, detti catacombe (gallerie sotterranee). Ma quando il cristianesimo diventò la religione ufficiale dell'impero, la chiesa, organizzata con una propria gerarchia, fece costruire appositi edifici per il culto, come la basilica e il battistero, in grado di accogliere l'intera comunità dei fedeli. Innalzati di solito dove era stato martirizzato o sepolto un santo (come la Basilica di San Pietro), questi edifici vennero spesso eretti con marmi recuperati dalle costruzioni romane in rovina. Lo scopo non era solo quello di risparmiare, ma anche di sottolineare il carattere romano di queste costruzioni.
L'arte bizantina si è sviluppata nell'arco di un millennio, tra il IV ed il XV secolo, prima nell'ambito dell'Impero romano, poi di quello bizantino, che ne raccolse l'eredità. Le caratteristiche più evidenti dei canoni dell'arte bizantina sono la religiosità, l'anti-plasticità e l'anti-naturalismo, intese come appiattimento e stilizzazione delle figure, volte a rendere una maggiore monumentalità ed un'astrazione soprannaturale (smaterializzazione dell'immagine). Infatti il gusto principale dell'arte bizantina è stato quello di descrivere le aspirazioni dell'uomo verso il divino. L'arte bizantina ha comunque avuto espressioni stilistiche molto diverse fra di loro nei suoi oltre mille anni di vita, ma nell'Impero d'Oriente l'arte rimase quasi invariata.
Con arte longobarda si intende l'intera produzione artistica cui si diede corso in Italia durante il periodo e nel territorio della dominazione longobarda (568-774), con residuale permanenza nell'Italia meridionale fino al X-XI secolo, indipendentemente dall'origine etnica dei vari artefici, tra l'altro spesso impossibile da definire. Al loro ingresso in Italia, il popolo germanico orientale dei Longobardi portò con sé la propria tradizione artistica di matrice germanica, anche se già influenzata da elementi bizantini durante il lungo soggiorno del popolo in Pannonia (VI secolo); tale matrice rimase a lungo visibile nell'arte longobarda soprattutto nei suoi aspetti formali e ornamentali (simbolismo, horror vacui, decori fitomorfi o zoomorfi). In seguito al radicarsi dello stanziamento in Italia, ebbe inizio un vasto processo di fusione tra l'elemento germanico e quello romanico (latino-bizantino), che diede vita a una società sempre più indistinta.
Il romanico è quella fase dell'arte medievale europea sviluppatasi a partire dalla fine del X secolo all'affermazione dell'arte gotica, cioè fin verso la metà del XII secolo in Francia e i primi decenni del successivo in altri paesi europei (Italia, Inghilterra, Germania, Spagna). Il romanico rinnovò principalmente l'architettura e la scultura monumentale, quest'ultima applicata all'architettura stessa (come decorazione di portali, capitelli, lunette, chiostri...).
L'arte gotica nasce in un periodo compreso fra la metà del XII secolo e, in alcune aree europee, i primi decenni del XVI secolo. La novità più originale dell'architettura gotica è la scomparsa delle spesse masse murarie tipiche del romanico: il peso della struttura non veniva più assorbito dalle pareti, ma veniva distribuito su pilastri all'interno e nel perimetro, coadiuvati da strutture secondarie come archi rampanti e contrafforti. Lo svuotamento della parete dai carichi permise la realizzazione di pareti di luce, coperte da magnifiche vetrate, alle quali corrispondeva fuori un complesso reticolo di elementi portanti. Anche in scultura gli artisti di epoca gotica si mossero a partire dalle conquiste del secolo precedente, quali la ritrovata monumentalità, l'attenzione per la figura umana, il recupero della plasticità e del senso del volume. Le innovazioni furono radicali e si pervenne dopo molti secoli ad una rappresentazione della figura umana finalmente realistica e aggraziata. La pittura nel periodo gotico subì uno scarto temporale rispetto alle altre arti arrivando a un rinnovamento con un ritardo di tre-quattro decenni, grazie alla scuola italiana, grazie all'opera di Giotto.

Nel Rinascimento (XV sec.-XVI sec.) si ha una vera e propria rinascita delle arti. In architettura vengono reinterpretati gli ordini classici (dorico, ionico, corinzio) e gli edifici religiosi e civili vengono progettati con precisi criteri di proporzionalità tra le parti come nell'architettura romana e greca. Vengono, inoltre, ristrutturati molti edifici medievali e viene ampliato il tessuto urbano come a Firenze che tra il 1450 e 1470 vengono edificati trenta nuovi palazzi. Vengono costruite molte ville di campagna dove i nobili si recavano durante l'estate.

I principali architetti sono Filippo Brunelleschi (1377-1446) che realizzò la cupola della chiesa di Santa Maria del Fiore e l'ospedale degli innocenti a Firenze; Michelangelo Buonarroti (1475-1564) che realizzò la Sagrestia Nuova nella chiesa di San Lorenzo e la biblioteca Laurenziana a Firenze, progettò la cupola di San Pietro in Vaticano e restaurò piazza del Campidoglio, i Palazzi dei Conservatori e i Musei Capitolini; Donato Bramante (1444-1514) che usò la prospettiva illusoriamente nei suoi edifici per creare un effetto di uno spazio che si estende oltre i confini della realtà, un esempio è la chiesa di Santa Maria presso San Satiro; realizzò inoltre il Tempietto di San Pietro in Montorio e contribuì alla costruzione della basilica di San Pietro; Leon Battista Alberti (1406-1472) che scrisse il Trattato sull'Architettura e realizzò i modelli di chiesa e palazzo cittadino utilizzati per tutto il Rinascimento: la chiesa di Sant'Andrea a Mantova e il palazzo Rucellai a Firenze.

In scultura la figura umana è studiata nelle sue caratteristiche anatomiche, nelle sue proporzioni, nelle sue diverse posizioni e espressioni; viene inoltre riutilizzata la tecnica a cera persa, inventata dai romani e caduta in disuso nel Medioevo, per la realizzazione di sculture in bronzo. I principali scultori sono: nel primo Rinascimento Donato di Niccolò di Betto Bardi detto Donatello (1386-1466) che realizza numerose statue in bronzo, come il monumento equestre di Erasmo da Narni setto "Gattamelata" a Padova, e molti bassorilievi con la tecnica dello stiacciato da lui inventata, e Michelangelo Buonarroti che realizza la Pietà conservata nella basilica di San Pietro in Vaticano, e il David conservato a Firenze.
Il David non rappresenta solo l'eroe biblico che uccise Golia, ma rappresenta la forza della città di Firenze che riesce a distruggere qualsiasi nemico nel nome di Dio. I principali pittori sono Piero della Francesca (1420 circa-1492) che lavora ad Urbino per il Duca di Montefeltro; Andrea Mantegna (1431-1501) che dipinge molti palazzi dei marchesi Gonzaga, a Mantova; Francesco del Cossa (1436-1478) che realizza a Ferrara, per il Duca d'Este, il Salone dei Mesi nel palazzo Schifanoia; Paolo Uccello (1397-1475) che lavora a Firenze per i de' Medici, realizzando affreschi con temi del Gotico Internazionale (dame, cavalieri) utilizzando la tecnica della prospettiva; Sandro Botticelli (1445-1510) che realizza a Firenze dipinti con figure aggraziate ed eleganti come nella Nascita di Venere; Michelangelo Buonarroti (1475-1564) in cui, nei suoi dipinti, è evidente la mentalità di scultore: infatti le figure dominano il dipinto, hanno volumi solidi, compatti e imponenti e una muscolatura molto evidente come nel dipinto Tondo Doni conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze o nell'affresco del Giudizio Universale realizzato da Michelangelo, per papa Giulio II, nella Cappella Sistina; Raffaello Sanzio (1483-1520) che fu allievo del Perugino, anche se superò in un modo sorprendente il suo maestro, come è evidente nello Sposalizio della Vergine.
Il Manierismo è un movimento artistico, nato nella seconda metà del Cinquecento, che si ispirava ai grandi artisti del Rinascimento, in particolare a Michelangelo Buonarroti. Il Termine "Manierismo", coniato da Giorgio Vasari nel suo libro: "Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori; da Cimabue insine à tempi nostri" , deriva dal sostantivo "maniera". Inizialmente il Manierismo venne giudicato poco originale ma successivamente gli storici lo considerarono l'ultimo sviluppo del Rinascimento. Gli artisti più importanti sono Parmigianino, Rosso Fiorentino, Pontormo e i veneti Paolo Veronese e Tintoretto, gli architetti Palladio e Sansovino.
Per arte della controriforma si intende quella parte di arte europea della seconda metà del XVI secolo che è più fortemente influenzata dagli indirizzi teorici sull'arte sviluppati a seguito del Concilio di Trento.
Barocco indica lo stile dominante del XVII secolo. Il barocco diviene in brevissimo tempo, grazie alla sua esuberanza, alla sua teatralità, ai suoi grandiosi effetti e alla magniloquenza profusa su ogni superficie e con ogni materiale, lo stile tanto della Chiesa cattolica che delle monarchie europee, tese verso l'assolutismo. Caratteristiche fondamentali dell'architettura barocca sono le linee curve, dagli andamenti sinuosi, come ellissi, spirali o curve a costruzione policentrica, con motivi intrecciati tra di loro. Tutto doveva destare meraviglia e il forte senso della teatralità spinse l'artista all'esuberanza decorativa, unendo pittura, scultura e stucco nella composizione spaziale e sottolineando il tutto mediante suggestivi giochi di luce ed ombre. Furono privilegiati la monumentalità, gli effetti drammatici e i contrasti di luce. In particolare fu ricercato l'illusionismo, un effetto di inganno che traducesse in arte la perdita di certezze dominante nell'epoca. L'illusionismo, cioè la sovrapposizione tra realtà, rappresentazione e finzione, si manifestò in pittura con prospettive impossibili e giochi di specchi che rendevano un'immagine deformata della realtà
Il Rococò è uno stile ornamentale sviluppatosi in Francia nella prima metà del Settecento come evoluzione del tardo barocco, sotto il regno di Luigi XV. Si distingue per la grande eleganza e la sfarzosità delle forme, caratterizzate da ondulazioni ramificate in riccioli e lievi arabeschi floreali. Sono espresse soprattutto nelle decorazioni, nell'arredamento, nella moda e nella produzione di oggetti. Caratterizzato da delicatezza, grazia, eleganza, gioiosità e luminosità si poneva in netto contrasto con la pesantezza e i colori più forti adottati dal precedente periodo barocco. I motivi Rococò cercano di riprodurre il sentimento tipico della vita aristocratica libera da preoccupazioni o del romanzo leggero piuttosto che le battaglie eroiche o le figure religiose. Verso la fine del XVIII secolo il rococò verrà a sua volta rimpiazzato dallo stile neoclassico.
Neoclassicismo è il nome dato alla tendenza culturale sviluppatasi in Europa tra il XVIII ed il XIX secolo. Il neoclassicismo fu variamente caratterizzato, ma ben riconoscibile nelle varie arti, nella letteratura, in campo teatrale, musicale e nell'architettura. Nacque come reazione al tardo barocco e al Rococò; e si ispiró all'arte antica, in particolar modo verso quella greco-romana. Grande influenza nello sviluppo dello stile Neoclassico ebbero gli scavi di Ercolano e di Pompei, avviati dal 1738 (a Ercolano) e dal 1748 (a Pompei), da Carlo di Borbone, re di Napoli, che ispirarono, tra gli altri, Luigi Vanvitelli.
Il termine arte moderna denota lo stile e la concezione dell'arte propri di quell'epoca[3] e, più in generale, alle espressioni artistiche che esprimono una forma di «rifiuto» per il passato e di apertura alla sperimentazione[4]. Gli artisti moderni sperimentarono nuove forme visive e avanzarono concezioni originali della natura, dei materiali e della funzione dell'arte, alternando periodi più realisti (sia per le tecniche adottate che per i soggetti scelti) a periodi più "simbolisti" o "espressionisti" fino all'astrazione. La produzione artistica più recente è spesso definita come arte contemporanea, o arte postmoderna.
L'arte dopo l'era moderna si è trasformata seguendo i cambiamenti economici, globali, politici e socioculturali. La sempre maggior velocità e mole di scambi di idee, risorse economiche, informazioni e cultura intorno al globo avviene anche nel mondo dell'arte, rendendone difficile una caratterizzazione precisa. Molte delle barriere e distinzioni all'interno dell'arte sono cadute contribuendo ad una vivacità e multidisciplinarità tipica dell'arte contemporanea che ne ha fatto spesso ragione d'essere.
La storia dell'arte comprende tradizionalmente il campo delle arti visuali:
In un concetto più ampio può arrivare a comprendere tutte le "sette arti", comprendendo le arti performative, la letteratura e la musica.
▪︎ J. D. Fiorillo ▪︎ J. B. Seroux D'Agincourt ▪︎ L. Cicognara ▪︎ F. Kugler ▪︎ A. Springer ▪︎ P. Selvatico ▪︎ G. B. Cavalcaselle ▪︎ J. A. Crowe ▪︎ L. Moretti ▪︎ A. Venturi ▪︎ R. Longhi ▪︎ P. Toesca ▪︎ B. Berenson
La storia dell'architettura studia il succedersi delle vicende che hanno caratterizzato la progettazione architettonica dalla nascita dell'umanità ai giorni nostri. Le opere architettoniche possono essere studiate sia con approccio diacronico, analizzando gli stili succedutisi nei vari periodi storici, o sincronico, studiando le differenze che intercorrono tra le varie aree geografiche nello stesso periodo.
Per un'opera complessa quale un edificio non bisogna considerare solo le valenze estetiche, ma è fondamentale valutare anche la funzione che tale opera ha avuto nella società che l'ha prodotta e le qualità tecniche che hanno determinato il suo stare in piedi. Quindi molti studiosi di architettura tendono a considerare un edificio come un "organismo" in cui si devono fondere coordinatamente:
Si tratta degli elementi identificati già nel I secolo da Marco Vitruvio Pollione, architetto e ingegnere romano, nel trattato De Architectura.
I primi esempi di "architettura" come sintesi tra stabilità, funzionalità e bellezza non sono quindi da ricercare nell'edilizia di tipo abitativo (in antico dettata solo da basilari esigenze di sussistenza), ma negli edifici collettivi (religiosi o civili) delle prime civiltà, come quella mesopotamica o egizia: in tali opere confluivano infatti tutti gli sforzi di una comunità, compresa l'esigenza di abbellimento quale specchio del proprio prestigio e ricchezza.
Nella realizzazione di un'opera architettonica hanno da sempre concorso sia le richieste della committenza sia l'estro e la fantasia dei progettisti. Siccome ogni edificio ha primariamente uno scopo pratico, il progettista deve collaborare a stretto contatto con le committenze per poter comprendere e tradurre nel progetto le loro necessità. Per questo motivo, al contrario di altre forme artistiche dove l'artefice si è ormai affrancato dalla domanda, la convergenza degli interessi di progettisti e committenti è rimasto un concetto chiave.
Tuttavia la storia dell'architettura non è influenzata solo dalla committenza e dagli architetti, ma principalmente da una vasta serie di fattori esterni[1]:
Inoltre, per agevolare lo studio della storia dell'architettura si possono classificare i vari fenomeni architettonici secondo diversi "caratteri"; queste classificazioni possono essere tra loro combinate in molteplici modi che forniscono diverse prospettive di lettura.

È l'architettura sviluppata nell'ambito della civiltà minoica, la civiltà cretese dell'età del bronzo circa 3000-1050 a.C.
È l'architettura sviluppata nell'ambito della civiltà micenea, che si sviluppò in Grecia circa 1500-1100 a.C.
L'architettura greca viene suddivisa, come tutta l'arte greca, convenzionalmente in tre periodi: nel periodo arcaico abbiamo la costituzione degli ordini architettonici e l'erezione dei primi templi. In età classica, corrispondente al V e IV secolo a.C., l'erezione di capolavori come i templi dell'Acropoli di Atene, in età ellenistica la diffusione del linguaggio greco in buona parte del Mar Mediterraneo.
Rispetto all'architettura greca, di cui rielabora talvolta il linguaggio, l'architettura romana si basa sulla conquista dello spazio interno dando vita a quella che Siegfried Gideon definì la concezione occidentale dello spazio. Le straordinarie realizzazioni di età imperiale furono rese possibili grazie anche all'alto livello tecnologico raggiunto dall'ingegneria romana del tempo.
È un'architettura soprattutto ecclesiastica. Rielabora forme romane come la basilica, adattandola al culto cristiano.
L'architettura bizantina è l'architettura che si è sviluppata nell'Impero Romano d'Oriente e nelle regioni sottoposte al suo influsso politico e culturale, come l'esarcato di Ravenna. Dopo la caduta dell'Impero d'Oriente ebbe seguito nelle aree europee e asiatiche di confessione ortodossa, come nell'Impero russo.
Nei territori dei Franchi tra il V e l'VIII secolo.
Nei territori dei Franchi tra l'VIII e l'XI secolo.
Sviluppata in Italia tra VII e VIII secolo nei territori soggetti al Regno longobardo, mescola elementi bizantini e sviluppi originali. Le testimonianze sono scarse, poiché gran parte degli edifici è stata rimaneggiata in epoche successive.
L'architettura romanica è l'architettura dell'occidente europeo prevalentemente nei secoli XI e XII. Le maggiori realizzazioni sono edifici religiosi come cattedrali, pievi e abbazie ed edifici civili come castelli e palazzi.
Nasce nella metà del XII secolo nell'Ile de France e si diffonde in tutta Europa. È caratterizzata da una innovativa e ardita tecnica costruttiva e dalla ricerca di nuove forme spaziali. Vedi anche tecniche costruttive dell'architettura gotica.
L'architettura del Rinascimento ebbe origine a Firenze, agli inizi del Quattrocento, principalmente grazie all'operato di alcuni artisti e intellettuali fiorentini come Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti.
L'architettura del Rinascimento è caratterizzata dalla ripresa degli ordini e delle proporzioni dell'architettura del mondo classico, in particolare di quello romano. Importante esponente è Andrea Palladio.
L'architettura barocca è quella fase della storia dell'architettura europea che comprende i secoli XVII e XVIII e che, nell'ultima sua fase, prende il nome di rococò. Il termine barocco, originariamente dispregiativo, indicava la mancanza di regolarità e di ordine. L'architettura del barocco, se da un lato mantiene la grammatica compositiva classica, dall'altro ne infrange le regole sintattiche, mettendo al centro l'interpretazione soggettiva e priva di regole dell'artista.
L'architettura del neoclassicismo o neopalladianesimo si sviluppa fra la seconda metà del XVIII secolo e il XIX secolo. I teorici di questo periodo sostengono la necessità che l'architettura sia derivata da basi razionali, rispecchiate negli ordini classici, e che si eviti la licenza e il "cattivo gusto" che avrebbe, a parer loro, caratterizzato l'architettura del XVII secolo e del rococò.
L'architettura della seconda metà dell'Ottocento è caratterizzata dallo storicismo e dall'eclettismo, in particolare dalla ripresa dell'architettura neogotica e in seguito anche di altri "stili", come il neogreco, il neoromanico o il neobarocco.
L'architettura moderna è caratterizzata da una molteplicità di tendenze. Per Movimento Moderno si intende in particolare l'architettura razionalista che si è sviluppata a partire dagli anni trenta del XX secolo, in particolare attorno alle figure di Walter Gropius, Mies van der Rohe Le Corbusier. Altro importante maestro è Frank Lloyd Wright con la sua architettura organica.
Dopo la seconda guerra mondiale l'architettura ha preso strade divergenti, caratterizzate tuttavia dall'uso massiccio di nuovi materiali e dall'attenzione all'impatto urbano e ambientale. Alcuni esempi di correnti dell'architettura contemporanea sono: il neorealismo architettonico, il brutalismo, l'architettura postmoderna, l'architettura high-tech e il decostruttivismo.

L'illuminismo fu un movimento politico, sociale, culturale e filosofico che si sviluppò in Europa nel XVIII secolo. Nasce in Inghilterra dopo la guerra civile, si diffonde poi in Francia, dove ebbe il suo massimo sviluppo, e successivamente in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il termine viene dal francese Lumière, cioè la "luce", capace questa di illuminare le menti degli uomini e condurli verso un percorso di progresso, di pace, di emancipazione, di tolleranza, di felicità e di cosmopolitismo[2].
In senso lato, il termine "illuminismo" è passato a significare genericamente qualunque forma di pensiero di tipo razionale che voglia "illuminare" la mente degli uomini, ottenebrata dall'ignoranza e dalla superstizione, servendosi della critica, della ragione e dell'apporto della scienza.[3]
L'Illuminismo fu preparato da grandi avvenimenti e cambiamenti avvenuti nei secoli precedenti, quali la Gloriosa rivoluzione inglese del 1689, lo spirito critico iniziato con il Rinascimento, il movimento rivoluzionario della Riforma protestante, la trasformazione economica della società moderna e soprattutto la mentalità scientifica del Seicento[4] con i suoi effettivi progressi, in particolare nel campo delle indagini fisico-matematiche, condotte con rigore metodologico. Tutta la storia è chiamata davanti al tribunale della ragione critica, la quale è antitradizionalista e ha funzione educatrice e liberatrice. La demolizione si esercita sulla realtà effettuale, sulle istituzioni, sui costumi, penetra nel vivo della società suggerendo programmi di ricostruzione, piani di attività, idee innovatrici.[5]
"L'età dei lumi": con questa espressione, che mette in evidenza l'originalità e la caratteristica di rottura consapevole nei confronti del passato, si indica la diffusione in Europa del nuovo movimento di pensiero degli illuministi francesi. Le basi su cui questa organizzazione fu costruita, sebbene spesso non accreditate a causa delle violente persecuzioni qualora se ne fosse riconosciuta l'eredità, furono poste dal filosofo olandese Baruch Spinoza, uno dei più importanti teorici della tolleranza religiosa e politica e del regime democratico. Voltaire, Montesquieu, Fontenelle, nonostante avessero letto Spinoza, riconoscevano tuttavia più spontaneamente di essersi ispirati a quella filosofia inglese fondata sulla ricerca empirica e sulla conoscenza scientifica che sorse dopo lo spinozismo e che discese da esso, elementi essenziali del pensiero di Locke e di Newton e David Hume che risalivano a loro volta a quello di Francis Bacon.[6]
Se l'illuminismo assunse prevalentemente un'impronta francese questo si deve alle particolari condizioni storiche della Francia del XVIII secolo. Lo sviluppo della borghesia durante il regno di Luigi XIV è assicurato dall'assolutismo monarchico ed è fondato sulla distinzione tra l'uomo privato e quello pubblico. Il suddito potrà fare i suoi affari ed esprimere una certa libertà di pensiero ma questa non dovrà mai entrare in conflitto con l'autorità del sovrano.
Alla borghesia evoluta, alla fronda nobiliare e al movimento ugonotto, che continuano nascostamente ad esercitare la loro critica, si aggiungono i nuovi finanzieri, creditori dello stato ma privi di potere politico che esprimono il loro dissenso nelle società segrete come quella della Massoneria. Quanto più repressa sarà la loro contestazione politica tanto più diverrà appariscente evidenziando così l'illuminismo francese che, rispetto a quello inglese, meno condizionato dal potere politico, diverrà il rappresentante dell'illuminismo in generale.

Una particolare funzione sociale e politica venne svolta nel "Siècle des Lumières" dai salotti letterari: una tradizione culturale già presente in Francia dai tempi di Luigi XIV, quando ci si riuniva a intervalli regolari presso una signora di mondo nei bureaux d'esprit.[7]
Gli incontri erano ora organizzati da alti membri dell'alta borghesia o dell'aristocrazia riformista francese che erano soliti invitare in casa loro intellettuali più o meno noti per conversare e discutere su temi d'attualità o argomenti particolarmente graditi all'anfitrione come accadeva nel salotto di Madame Geoffrin, che invitava celebrità letterarie e filosofiche come Diderot, Marivaux, Grimm, Helvétius o nel salotto del barone d’Holbach, le premier maître d'hôtel de la philosophie, (primo direttore dell'albergo della filosofia)[8] nella cui casa si riunivano Diderot, d’Alembert, Helvétius, Marmontel, Raynal, Grimm, l'abate Galiani e altri filosofi. In genere nei salotti si leggevano opere giudicate politicamente eretiche dall'assolutismo monarchico o si discuteva di cosa stesse accadendo fuori del mondo salottiero.
In questo ambiente culturale svolgono un ruolo preminente le donne, le salonnièries (salottiere) alle quali il nuovo ideale egualitario illuminista offriva l'opportunità di collaborare, mostrando le proprie doti intellettuali, ad un progetto radicalmente riformista non più riservato a una cultura soltanto maschile.[9]

Compito degli intellettuali illuministi, che si autodefiniscono philosophes o idéologues, deve quindi essere il coraggioso uso della ragione:
Questa è la responsabilità dell'intellettuale di fronte alla società in cui vive: un compito pedagogico di liberazione dalla metafisica, dall'oscurantismo religioso, dalla tirannia della monarchia assoluta. Questo programma educativo secondo Jean-Jacques Rousseau significherà riportare l'uomo al suo iniziale stato di natura trasformandone la spontanea bontà della condizione naturale in una conquista consapevole e definitiva della sua razionalità. Poiché
L'Illuminismo fu anche un movimento profondamente cosmopolita: pensatori di nazionalità diverse si sentirono accomunati da una profonda unità d'intenti, mantenendo stretti contatti epistolari fra loro. Furono illuministi Pietro Verri, Cesare Beccaria e Mario Pagano in Italia, Wolff, Lessing, Kant in Germania[13], Benjamin Franklin e Thomas Jefferson nelle colonie americane, Montesquieu, Voltaire e Rousseau in Francia.
Durante la prima metà del XVIII secolo, molti tra i principali esponenti dell'Illuminismo furono perseguitati per i loro scritti o furono messi a tacere dalla censura governativa e dagli attacchi della Chiesa, ma negli ultimi decenni del secolo il movimento si affermò in Europa ed ispirò la rivoluzione americana e successivamente quella francese.
Il successo delle nuove idee, sorretto dalla pubblicazione di riviste e libri (fra cui Lettere Persiane e Dei delitti e delle pene) e da nuovi esperimenti scientifici (come quelli di Franklin e Newton) inaugurò una moda diffusa persino tra i nobili e il clero. Alcuni sovrani europei adottarono le idee e il linguaggio dell'Illuminismo. Gli illuministi, sostenitori del concetto di filosofo-re che illumina il popolo dall'alto, guardarono con favore alla politica dei cosiddetti despoti illuminati, come Federico II di Prussia, Caterina II di Russia e Maria Teresa d'Austria.
La Rivoluzione francese, specie nel periodo compreso tra il 1792 e il 1794, espressione dell'ala più rivoluzionaria dell'Illuminismo, che è stato definito come "radicale"[14] pose fine alla diffusione pacifica, ma talvolta anche solo elitaria, dell'Illuminismo e, per i suoi episodi più sanguinosi, viene citata come motivo per esprimere una valutazione negativa sull'Illuminismo.

In senso più ampio si parla di "illuminismo" riferendolo anche al mondo greco antico nell'ambito, ad esempio, del pensiero dei sofisti[15], autori di una critica corrosiva alle presunte leggi di origine divina e all'antropomorfismo religioso. Ugualmente illuministi ante litteram possono essere ritenuti Democrito e gli atomisti, gli scettici e gli stoici e soprattutto Epicuro, che vuole liberare l'uomo dalla paura, indotta dalla religione, degli dei e della morte.[16]
Erede della ragione, intesa nel senso di Locke, l'illuminismo vuole adattare alla filosofia il metodo della fisica newtoniana affidando alla ragione la determinazione tanto delle proprie possibilità che dei propri limiti, indipendentemente da ogni verità che si presenti come rivelata o innata.
La fede nella ragione, coniugandosi con il modello sperimentale della scienza newtoniana, sembrava rendere possibile la scoperta non solo delle leggi del mondo naturale, ma anche di quelle dello sviluppo sociale. Si pensò allora che, usando correttamente la ragione, sarebbe stato possibile un progresso indefinito della conoscenza, della tecnica e della morale: convinzione questa che verrà successivamente ripresa e rafforzata dalle dottrine positiviste.
Fin dagli inizi gli illuministi presuppongono che la gran parte degli uomini, pur essendo stata creata libera dalla Natura (naturaliter maiorennes) si accontenti molto volentieri di rimanere "minorenne" per tutta la vita. Questa condizione è dovuta o a comoda pigrizia o a viltà, al non avere cioè il coraggio di cercare la verità. In ogni caso il risultato di questa non-scelta è la facilità per i più scaltri e per i detentori del potere di erigersi a guide di costoro: «Se io ho un libro che pensa per me, se ho un direttore spirituale che pensa per me...io non ho più bisogno di darmi pensiero di me. Non ho bisogno di pensare, purché possa solo pagare...».[17]
Gli interessati tutori imprigionano dunque i vili e i pigri in una «carrozzina da bambini» paventando loro i rischi che si corrono a voler camminare da soli. Non s'impara a camminare senza cadere, ma questo li terrorizza, per cui rimarranno infanti per tutta la loro vita.[18]
L'illuminista dovrà tutelare l'uomo ammaestrandolo a diventare "maggiorenne" usando la propria ragione per liberarsi dalla credenza irriflessa nelle verità già date, siano esse quelle innate nel campo conoscitivo, siano quelle rivelate dalla religione.
La ragione rifiuterà tutto quello che non deriva da essa con il principale compito di stabilire i propri limiti: una ragione dunque programmaticamente finita e orgogliosa di essere tale poiché, in quell'ambito limitato, che è quello dell'esperienza, essa potrà conoscere la verità sino in fondo.
Questo avverrà applicando la critica della ragione, attraverso cioè l'analisi, la discussione, il dibattito nei confronti di quell'esperienza che non è soltanto il complesso dei fatti fisici ma anche di quelli storici e sociali:
La definizione illuministica della ragione è ormai lontana da quella classica prevalentemente contemplativa. Ora è concepita come funzionale e operativa: la sua validità cioè è dimostrata dai risultati pratici che essa consegue: la razionalità è valida se è in grado di spiegare e ordinare i fatti in base a leggi di ordine razionale. Ragione, natura, spontaneità coincidono nella visione illuministica nella convinzione che la natura stessa abbia dotato ogni uomo della istintiva capacità di comprendere o, per dirla con l'illuminista radicale Andreas Riem, di «rischiarare secondo princìpi di una pura logica e per la promozione dell'utile tutti gli oggetti del mondo delle idee, tutte le opinioni umane e i loro effetti, e tutto quanto ha influenza sull'umanità»[20]. Tale capacità lo rende uguale a tutti gli altri a condizione che esso sia liberato dalla corruzione della superstizione e dell'ignoranza. L'uomo, liberato dalle incrostazioni del potere, userà correttamente e spontaneamente la propria ragione (come secondo gli illuministi dimostrerebbe il comportamento naturale del cosiddetto "buon selvaggio") per procedere alla costruzione di uno Stato in cui le leggi, non più tiranniche, si fondino sul rispetto dei diritti naturali.
Quello del "buon selvaggio" fu un mito basato sulla convinzione che l'uomo in origine fosse un "animale" buono e pacifico, solo successivamente corrotto dalla società e dal progresso. Nella cultura del Primitivismo del XVIII secolo, il "buon selvaggio" era considerato più lodevole, più autenticamente nobile dei prodotti dell'educazione civilizzata.
Nonostante l'espressione "buon selvaggio" fosse già comparsa nel 1672 in La conquista di Granada di John Dryden (1672), la rappresentazione idealizzata di un "gentiluomo della natura" fu ripresa dal Sentimentalismo del secolo successivo.
Il concetto di "buon selvaggio" incarna la convinzione che senza i freni della civilizzazione gli uomini siano essenzialmente buoni, le sue fondamenta giacciono nella dottrina della bontà degli esseri umani, espressa nel primo decennio del Settecento da Anthony Shaftesbury, che incitava un aspirante autore « [...] a cercare quella semplicità dei modi, e quel comportamento innocente, che era spesso noto ai meri selvaggi; prima che essi fossero corrotti dai nostri commerci.»[21]
Il mito del buon selvaggio fu alimentato dall'azione missionaria dei Gesuiti[22], iniziata fin dal XVII secolo nelle loro reducciones del sud America, soprattutto nel Paraguay, consistente nella realizzazione di centri (reducciones de indios) per l'evangelizzazione delle popolazioni indigene allo scopo di creare una società con i benefici e le caratteristiche della cosiddetta società cristiana europea, però priva dei vizi e degli aspetti negativi. Gli indios apparivano specialmente adatti per questo progetto data la loro natura essenzialmente recettiva dell'educazione dei Gesuiti. Ma ciò che faceva pensare che essi incarnassero la primitiva bontà dell'uomo non civilizzato erano le loro naturali inclinazioni artistiche soprattutto per la musica.
Nell'illuminismo fu poi soprattutto Rousseau a propagandare la tesi del buon selvaggio, asserendo nel suo Contratto sociale che «l'uomo è nato libero e tuttavia ovunque è in catene» (Capitolo I). Voltaire gli rispose polemicamente con vena ironica che «a leggere il vostro libro vien voglia di camminare a quattro zampe, ma avendone sfortunatamente persa l'abitudine da più di sessant'anni mi è impossibile riprenderla ora».[23]


La conoscenza fondata sulle potenzialità interiori della stessa ragione si svolge nel campo del finito e del limitato secondo l'insegnamento di Locke. Occorrerà fornire quindi la ragione di un metodo oggettivo rappresentato dall'analisi matematica che faccia affidamento più all'aritmetica che alla geometria poiché quest'ultima, come si è visto in Cartesio, può portare a elaborazioni metafisiche sganciate da ogni esperienza.
L'aritmetica, invece, è uno strumento di ricerca che deve necessariamente riferirsi all'esperienza, fonte di ogni contenuto concreto. La stessa aritmetica permette di trovare tra i fatti analizzati dei principi invariabili e una legge:
Il discorso iniziato da Galilei e concluso da Newton arriva dunque a compimento con l'illuminismo, che estende il metodo analitico dai fatti fisici a quelli sociali, etici e psichici; in breve, a tutta la realtà umana:
L'illuminista si dichiara nemico dell'esprit de système, di chiara matrice razionalistica, inteso come la pretesa di definire una volta per tutte la realtà partendo da principi fissi e determinati, com'era in Cartesio, ma adopera lo spirito sistematico iniziando dai fatti: un atteggiamento sistematico inteso come una ricerca razionale per la conoscenza dei fatti dopo averli analizzati rifiutando ogni impostazione aprioristica e arrivando alla definizione di leggi generali solo dopo l'accurato esame dei fatti stessi.

Il mondo è una macchina che ha un ordinamento di leggi al suo interno che esclude qualsiasi teoria finalistica:
Il rifiuto di ogni metafisica e la visione naturalistica della realtà non comportano per gli illuministi una concezione materialista, che anzi in genere essi rifiutano[28]: «Voltaire non si sente l'animo di decidersi né per il materialismo né per lo spiritualismo. Egli ripete spesso:
Il materialismo infatti, secondo gli illuministi, non è altro che un falso travestimento della vecchia metafisica che vuole offrire la facile spiegazione onnicomprensiva e totale dell'universo. Se essi sostengono talora il materialismo lo fanno per ragioni politiche e morali, come polemica ed estrema protesta contro le imposizioni politiche e religiose del loro tempo. Solamente D'Holbach e La Mettrie sostengono in maniera convinta e scientifica la concezione materialistica.[30]

Emblema dell'illuminismo francese, assieme al pensiero di Voltaire, sarà la grandiosa opera dell'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, che in 28 volumi, 11 tavole e 60 000 voci, pubblicati dal 1751 al 1772 da un consistente gruppo di intellettuali sotto la direzione di Diderot e D'Alembert, diffonderà i principi illuministici non solo in Francia ma, attraverso numerose traduzioni, in tutta Europa.
L'opera si presenta come arditamente innovativa rispetto ai vecchi dizionari enciclopedici: essa vuole essere «un quadro generale degli sforzi dello spirito umano in tutti i generi e in tutti i secoli.»[31] Oltre ad essere un'opera di informazione, l'Enciclopedia era quindi anche un'opera di propaganda, tramite la quale i suoi autori si proponevano di convincere il vasto pubblico della validità delle idee illuministe.
D'Alembert fu costretto a ritirarsi dalla direzione dell'opera nel 1759, in seguito al divieto di pubblicazione del Consiglio di Stato. Diderot continuerà la preparazione clandestina di altri volumi.
La pubblicazione dell'Encyclopédie incontrò infatti diversi ostacoli e resistenze da parte dell'aristocrazia intellettuale di corte, vicina alla Sorbona, e da parte della Chiesa cattolica: il governo francese ne bloccò per due volte la stampa e gli ultimi due volumi dovettero uscire clandestinamente. Ciò nonostante l'Enciclopedia fu interamente pubblicata negli anni fra il 1751 e il 1772, e ottenne un grande successo sia in Francia che nel resto d'Europa, dove il francese era ormai divenuto la lingua delle persone colte.
L'Enciclopedia si propone di eliminare dal sapere sino allora acquisito ogni connotazione non provata razionalmente e quindi ordinare con un criterio alfabetico le nostre conoscenze: questo compito
I criteri di compilazione risponderanno a questi punti principali: il metodo analitico per la filosofia sulla base dell'empirismo lockiano e il metodo della fisica newtoniana sulla base del pensiero baconiano da cui D'Alembert, riprendendone la tripartizione di memoria, ragione e immaginazione, vi fa corrispondere storia, filosofia e arte.[33]
Gli articoli dell'Enciclopedia trattano i più svariati argomenti con un tono ora rivoluzionario ora apparentemente ingenuo: si parla di tolleranza, di guerra, di progresso, di privilegi ma anche di calze, di cinesi...
Emergono dall'opera anche le nuove concezioni dell'economia con la glorificazione della macchina, del nuovo sistema industriale e le nuove teorie fisiocratiche che fondano la ricchezza di una nazione su i beni e i prodotti naturali cioè sull'agricoltura.

Come banditore del nuovo sapere si affianca all'Enciclopedia l'opera di Voltaire, che inizia la sua carriera letteraria come drammaturgo, poeta e autore di pamphlet (opuscoli satirici e polemici), saggi, satire e racconti brevi nei quali divulga la scienza e la filosofia della sua epoca. Il filosofo intrattiene inoltre una voluminosa corrispondenza con scrittori e sovrani europei.
Egli riprende tutti i temi tipici dell'illuminismo difendendoli con uno spirito caustico che non risparmia filosofi, clero e sovrani ma che non gli pone remore nell'accettare l'incarico di consigliere di Federico II di Prussia.
Voltaire crede nel progresso annunciato dall'illuminismo ma non è disposto a farne un dogma: «un giorno tutto andrà meglio, ecco la nostra speranza; ogni cosa va bene, ecco la nostra illusione»; critica il pessimismo ma beffeggia l'ingenuo ottimismo razionalistico di Leibniz[34] Al fondo del pensiero di Voltaire vi è la concezione dell'uomo ormai padrone della natura e facitore di un mondo né ottimisticamente esaltato né pessimisticamente condannato come il peggiore dei mondi possibili: occorre «lasciare andare il mondo come va, perché, se tutto non è bene, tutto è passabile».[35]

Attraverso l'esame critico della storia, l'illuminista può riconoscere la continuità dell'opera della ragione e denunciare gli errori e le contraffazioni con cui erano state tramandate sino ad allora le vicende umane allo scopo di mantenere gli uomini nella superstizione e nell'ignoranza. Nella storia così come sinora veniva presentata
Pierre Bayle per primo si dedicherà nel suo Dizionario storico e critico (1697) alla compilazione di una «raccolta degli errori e delle falsità» da cui deve essere epurata la storia come fino ad allora è stata presentata. Egli è un minuzioso e preciso raccoglitore di fatti attestati da documenti e testimonianze così numerose che Ernst Cassirer (1874–1945) lo considera il fondatore dell'acribia storica.
Il criterio sommo dunque della ricerca, per lo storico neutrale, è quello di scoprire come vera storia quella che segna la vittoria della ragione sull'ignoranza e per questo dall'illuminismo viene condannato in blocco il medioevo come età di fanatismo e oscurantismo religioso mettendo da parte gli aspetti positivamente culturali di quel periodo.

La mutevolezza degli avvenimenti storici è solo apparente: al di là di queste differenze l'illuminista coglie il lento ma costante emergere sulla superstizione e l'errore l'elemento immutabile della ragione:
Per Lessing la storia come ricerca della verità comincia solo con l'Illuminismo; tutto ciò che l'ha preceduta è una sorta di "pre-istoria".[39]
Sarà il romanticismo a rilevare nella concezione illuminista della storia la mancanza di una visione unitaria e concreta, che originava dall'astrattezza del concetto astorico di ragione, identificato con la pura e semplice naturalità. Gli illuministi, cioè, non colgono l'interdipendenza tra l'uso della ragione che opera nella storia e le vicende economiche, sociali e culturali che realmente si sviluppano nella storia; essi riportano ogni differenza o sviluppo nella storia all'opposizione ragione-ignoranza.

Da questa visione della storia dove prevale la ragione naturale universale ed eterna emergono i temi politici della tolleranza, uguaglianza e libertà, intesi come valori politici naturali ed universali.
Ma l'uguaglianza per gli illuministi non comporta uguaglianza sociale o politica: l'essenziale è che il sovrano rispetti i diritti naturali: è trascurabile che egli sia un sovrano assoluto. È vero che ogni uomo per natura è uguale agli altri, ma questo non comporta la parità tra i cittadini:
Così anche per il concetto della tolleranza l'illuminismo risente dei suoi limiti storici quando lo collega all'idea di emulazione e ai principi economici della libertà di scambio e della libera concorrenza:
La libertà e l'uguaglianza sono riconosciute per gli illuministi solo a coloro che sanno "bene usare" della ragione, e se "per natura" ne sono incapaci è giusto che nella vita civile essi siano sottoposti a chi sa ben governare: il "popolo", che ha dimostrato di fare cattivo uso della ragione non conseguendo la proprietà privata, va rispettato nella sua umanità ma va guidato dall'alto:


La semplice ragione non fa tutti uguali allo stesso modo: «è la proprietà che fa il cittadino»[44]
Le simpatie politiche degli illuministi sono rivolte alla monarchia costituzionale, che per il suo carattere moderato dà garanzia di ordine e di pace favorendo l'uguaglianza, oppure sono disposti a concedere fiducia anche al dispotismo illuminato:
La Natura e la ragione uguale per tutti rendono gli uomini fratelli al di là di ogni differenza etnica o nazionale. La fratellanza si traduce nell'ideale politico del cosmopolitismo.
Quando però la parola cosmopolite fu immessa nel 1762 nel vocabolario dell'Accademia francese se ne dava una connotazione negativa[45]:
Il giudizio sul cosmopolitismo mutò radicalmente dopo gli avvenimenti della Rivoluzione francese e nell'edizione del vocabolario del 1798 appare scritto a proposito del termine cosmopolite:
Al di là dei limiti storici, queste idee di libertà, uguaglianza, tolleranza per merito degli illuministi divennero patrimonio comune della cultura della Francia che cercò di esprimerli nella Rivoluzione e poi di esportarle nel resto d'Europa.
Collegata alla visione illuministica della storia e alla fiducia nella ragione è l'idea fondamentale che il progresso dell'uomo, senza sottovalutare gli ostacoli posti dai diversi costumi e tradizioni, sia inarrestabile.

Gli illuministi, inoltre, criticarono pesantemente l'uso della tortura e della pena di morte portando a radicali riforme giudiziarie come quelle di Maria Teresa d'Austria e di Pietro Leopoldo. La principale opera in questo senso è il libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, molto ammirato da Voltaire e Diderot.
L'impegno riformistico e la tensione volontaristica a mutare i rapporti sociali sono caratteristiche comuni ai politici dell'Illuminismo che accantonarono la trattazione dei problemi politici in chiave di ragion di Stato e di prudenza o arte di governo.[47]

Tipico del pensiero illuminista è il rifiuto di ogni religione rivelata e in particolare del Cristianesimo, ritenuto origine degli errori e della superstizione. Da qui la scelta del deismo come religione naturale e l'identificazione della religione con la morale.
Non considerando le posizioni materialistiche ed atee, come quelle dell'ultima fase del pensiero di Diderot, il deismo si ritrova nella maggior parte dei pensatori illuministi i quali, attraverso argomentazioni scientifiche, cercano di dimostrare l'esistenza di un Dio all'origine dell'universo. La meravigliosa macchina del cosmo fa infatti pensare che debba esserci come causa efficiente, non causa finale, un "eterno geometra":
Un Dio quindi che non interverrà più nella creazione dell'universo che egli «lascia andare come va» e che non interferisce nella storia dell'uomo che alla fine non sarà né condannato né premiato per le sue azioni.
La guida dell'uomo nella sua condotta morale diviene una religiosità laica, trasformazione della religione in morale naturale i cui precetti sono uguali per tutti gli uomini:
Tra i doveri naturali va annoverato il nuovo concetto rivoluzionario di tolleranza che viene spesso riferito alla vita economica applicando il concetto illuministico della ragione operativa, nel senso di giudicare la razionalità dai suoi risultati pratici:
Questo metodo di giudizio riguarda anche la morale: per gli illuministi è moralmente buono solo ciò che rende possibile il conseguimento dell'utile sociale.[47]
Lo stesso valore di tolleranza non esclude che si possa professare la fede in una religione rivelata: questo però sarà consentito solo nell'ambito della morale privata e non in quello della morale pubblica:
L'atteggiamento dell'Illuminismo nei confronti della religione cristiana e dei suoi rapporti col potere civile non furono uguali dappertutto: se in Inghilterra i problemi legati alla lotta contro l'assolutismo monarchico si erano già in parte risolti, seppure faticosamente, con l'editto di tolleranza del 1689, che poneva fine ufficialmente alle persecuzioni religiose e relegava la fede all'ambito soggettivo-individuale, nell'Europa continentale l'illuminismo «mantenne una dura avversione per la Chiesa Cattolica»[54]: «gli Stati cominciarono ad assumere un atteggiamento indipendente; si liberarono da ogni rispetto per la politica del Papato; rivendicarono per i loro affari interni, un'autonomia che concedeva alla curia un'influenza sempre minore, anche nelle questioni ecclesiastiche»[55]
I gesuiti, intransigenti difensori del primato papale, sulla spinta dei conflitti crescenti tra chiesa e stato, nonché di un'opinione pubblica che ne chiedeva l'annientamento, vennero espulsi da quasi tutti i paesi europei:[57] «Cominciò nel 1759 il Portogallo seguito dalla Francia (1762), dalla Spagna (1769), da Napoli e da Parma signoreggiate da principi borbonici. Non fu estranea a questa misura, per quanto riguarda le colonie spagnole e portoghesi, l'avversione dei coloni per le reducciones de indios, i villaggi costruiti dai gesuiti per raccogliervi gli indigeni e salvarli dallo sfruttamento degli encomenderos.[58]»
Il papa Clemente XIV nel 1773 con il breve Dominus ac Redemptor risolse di sopprimere la Compagnia di Gesù.[59][60][61] «I beni dell'ordine furono incamerati e destinati, in gran parte, alla creazione di opere pubbliche gestite dallo Stato, che presero il posto delle scuole gestite dai Gesuiti.[58]». La compagnia tuttavia non scomparve del tutto in Europa, in quanto in Russia, Caterina la Grande, pur essendo molto sensibile allo spirito illuminista, rifiutò la delibazione papale e mantenne vivo l'ordine.
Fu inoltre a seguito all'apertura del dibattito sulla religione e del suo ruolo nella società, che trovava un confronto con i pensatori giansenisti dell'epoca, che vennero scritti saggi critici sull'Inquisizione, come la Storia generale dell'Inquisizione, di Pietro Tamburini[62].
L'Inquisizione venne descritta come il luogo per eccellenza nel quale, tramite ripetuti crimini e torture, si esprimeva l'autentica ortodossia cattolica, spesso peraltro resa un tutt'uno con quella protestante.[63]
Voltaire nel suo Dizionario filosofico introduce la voce "Inquisizione" scrivendo:
e, dopo una disamina della storia dell'inquisizione, termina commentando le procedure del tribunale dell'inquisizione:
Secondo due storici revisionisti Edward Peters (1988)[65] e Henry Kamen (1997)[66] queste analisi avrebbero operato uno stravolgimento dei dati storici sull'Inquisizione, distorsione che chiamano leggenda nera dell'Inquisizione o del "secolo dell'intolleranza". Questa stortura storica sarebbe stata opera di ambienti protestanti e, a seguire, illuministi, a partire almeno dal XVI secolo, con l'obiettivo di screditare l'immagine sia della Chiesa cattolica, sia dell'Impero spagnolo.
Nell'Ottocento l'illuminismo fu giudicato come un movimento di pensiero che aveva rivoluzionato il mondo: Hegel e Marx, pur avanzando critiche, considerano il pensiero illuminista come una conquista definitiva dell'umanità.
Hegel contesta però all'illuminismo il fatto di non aver colto il vero senso della Storia dove veniva fatta agire una ragione astratta e non la realtà dello Spirito assoluto.
Marx esalta l'illuminismo per la sua critica alla religione ma evidenzia i limiti di questo movimento culturale legati alla classe borghese che l'ha espresso: esso infatti non ha colto i fondamenti economici della situazione storica da cui si è originato.
Accese critiche vengono rivolte all'Illuminismo nel periodo della Restaurazione da autori come De Bonald e De Maistre che negano che l'essenza dell'uomo sia la ragione: vale invece per determinare l'uomo una conoscenza religiosa. Infatti la critica individualistica della ragione che pretende di capire la realtà sulla base di principi immanenti non è altro che l'eterna presunzione dell'umanità: peccato di orgoglio che Dio può punire come ha fatto con il periodo del Terrore in Francia.[67]
Lo storicismo tedesco giudica positivamente la concezione illuminista della storia[68] e così anche l'illuminismo in genere come «una nuova visione del mondo».
Nel '900 Croce riprende l'interpretazione hegeliana dell'Illuminismo riconsiderandola nell'ambito del neoidealismo italiano[69] mentre la scuola di Francoforte con Max Horkheimer, risentendo della tragica esperienza della seconda guerra mondiale, ritiene che la portata rivoluzionaria dell'illuminismo sia fallita nel momento in cui l'uomo, che aveva imparato a padroneggiare il mondo con la sua ragione, ne sia stato poi dominato nel senso che la ragione soggettiva operava ormai senza chiedersi a quali fini si indirizzava limitandosi a trovare solo i mezzi più adatti per soddisfare quegli obiettivi che la società nel suo complesso aveva già indicato.[70][71]
Sulla linea dell'interpretazione marxista Lucien Goldmann rileva i limiti della concezione illuminista della storia ma esalta la funzione critica della ragione alla quale occorre rifarsi per una critica rivoluzionaria della società contemporanea.[72]
La scuola neo-kantiana di Marburgo evidenzia la positività della filosofia illuminista della conoscenza che scopre lo strumento del tutto nuovo della funzione critica della ragione nell'interpretazione dell'esperienza.[73]
Paul Hazard mette in luce nelle sue opere, attraverso l'esame di diversi aspetti, da quello filosofico a quello letterario e culturale, il grande merito dell'illuminismo nell'aver messo in crisi il vecchio mondo; d'altra parte sono da ascrivere all'illuminismo le contraddizioni, ereditate dall'età successiva, insite nei concetti di natura e di progresso.[74]
Un aspetto particolare dell'illuminismo è trattato da Reinhart Koselleck che descrive la nascita di questo movimento nell'ambito della situazione politica europea con una speciale attenzione alla Massoneria.[75]
Nell'ambito della letteratura critica cattolica sull'Illuminismo, sviluppatasi nella seconda metà del secolo XX, si sostiene come l'Illuminismo fosse caratterizzato dall'esaltazione di idee e principi (quali l'uguaglianza, la libertà, la fraternità) che sarebbero già stati storicamente proposti in Europa dal Cristianesimo e successivamente ripresi dagli illuministi e ripresentati avulsi dalla loro origine religiosa, se non addirittura in funzione anticristiana.
Joseph Ratzinger, futuro pontefice della Chiesa cattolica, scrive in proposito:
Non ha individuato i suoi precursori in primo luogo nelle altre religioni, ma in quell'Illuminismo filosofico che ha sgombrato la strada dalle tradizioni per volgersi alla ricerca della verità e verso il bene.... In quanto religione dei perseguitati, in quanto religione universale, al di là dei diversi Stati e popoli, ha negato allo Stato il diritto di considerare la religione come una parte dell'ordinamento statale, postulando così la libertà della fede.
Ha sempre definito gli uomini,... creature di Dio e immagine di Dio, proclamandone in termini di principio,... la stessa dignità.
In questo senso l'Illuminismo è di origine cristiana ed è nato non a caso proprio ed esclusivamente nell'ambito della fede cristiana. Laddove il cristianesimo, contro la sua natura, era purtroppo diventato tradizione e religione di Stato.
[...] È stato ed è merito dell'Illuminismo aver riproposto questi valori originali del cristianesimo e aver ridato alla ragione la sua propria voce.[76]»
Secondo lo storico cattolico del Medioevo Franco Cardini:
La visione della Chiesa e della stessa storia del cristianesimo in generale presentate dagli illuministi come un'epoca buia e irta di superstizioni sono state variamente contestate dalla letteratura critica d'ispirazione religiosa.[78][79][80]
Si è anche sostenuto, in particolare da parte del filosofo Friedrich von Hayek, che diversi furono gli aspetti e le eredità dell'Illuminismo, e cioè che andrebbero distinte delle forme di Illuminismo autenticamente laiche e liberali, ispirate alla scuola anglo-sassone e kantiana, e altre invece di stampo totalitario e giacobino, di ascendenza francese.[81]
Quale sia oggi l'eredità dell'illuminismo percepibile nella società del XXI secolo è il tema trattato da Eugenio Scalfari nell'opera Attualità dell'illuminismo (ed. Laterza, 2001)[82], una raccolta di tredici interventi tra i quali quelli di Umberto Eco, Umberto Galimberti, Norberto Bobbio, Lucio Villari e Gianni Vattimo che si possono riassumere nella considerazione che «l'illuminismo in quanto "sistema culturale" ha prodotto una cesura nella storia dell'Occidente cristiano, un taglio netto che ha determinato epocali cambiamenti materiali e di mentalità...ma esso ha anche evocato spettri e alimentato illusioni, suscitato conflitti e inasprito contrasti, non da ultimo proprio perché con l'affermazione dell'illuminismo si è imposto definitivamente il processo di secolarizzazione sociopolitica e di laicizzazione culturale della società europea»[83] Nell'età contemporanea valgono quindi ancora
Nella seconda metà del XX secolo, a livello accademico, in Italia si è assistito allo sviluppo di una corrente filosofica denominata "neo-illuminismo"[85], i cui massimi rappresentanti furono Nicola Abbagnano e Ludovico Geymonat.
Contrastando l'oscurantismo, il fanatismo, il dogmatismo e la superstizione l'Illuminismo ha beneficiato l'umanità in vari ambiti: la politica, l'economia, il diritto, la scienza, la cultura e l'arte. I lasciti più importanti furono:
L'Illuminismo ha quindi contribuito a trasformare la società europea e a influenzare la cultura mondiale, aprendo la strada all'età moderna e contemporanea.[86]
Il fascismo è un movimento politico d'estrema destra fondato da Benito Mussolini nel 1919, che prese il potere in Italia e governò il Paese come regime totalitario dal 1922 al 1943 nel corso del cosiddetto ventennio fascista.
Nato nell'intervallo tra le due guerre mondiali e nel contesto di movimenti estremisti di massa sorti dalla crisi economica e politica dello Stato liberale, si caratterizzò fin dall'inizio per il ricorso alla violenza come metodo di lotta politica (squadrismo), per l'ostilità alla democrazia e alle sue istituzioni, per l'avversione al bolscevismo e la promozione delle spinte irredentiste ed espansioniste italiane frustrate dall'esito della prima guerra mondiale, secondo l'idea della vittoria mutilata.
Già organizzato con i Fasci di combattimento in lista elettorale e sconfitto alle elezioni del 1919, virò dalle primitive istanze sociali del programma di San Sepolcro a quelle più marcatamente borghesi e antibolsceviche, rendendosi protagonista della reazione violenta nel biennio rosso e affermandosi rapidamente presso il ceto medio e nelle aree rurali. Entrò infine in parlamento nel 1921 in coalizione con nazionalisti e liberali e si costituì in Partito Nazionale Fascista (PNF).
Dopo la presa del potere con la marcia su Roma e una prima fase di debole compromesso con le altre forze politiche, si fuse con il movimento nazionalista e si assicurò la vittoria alle elezioni del 1924; ma la denuncia delle violenze e intimidazioni che avevano segnato la consultazione elettorale ebbe come risposta l'assassinio di Giacomo Matteotti e sancì la vittoria delle componenti più intransigenti del fascismo, trainando l'Italia verso il regime dittatoriale a partito unico (Stato fascista), che esautorava di fatto la monarchia e stravolgeva lo Statuto Albertino.
Il regime fascista, evolutosi in dittatura personale di Mussolini (designato anche ufficialmente Duce e fatto oggetto di culto della personalità) perseguì una politica estera colonialista e imperialista. Cauto in un primo tempo verso la Germania nazista, vi strinse alleanza nel 1936 (Asse Roma-Berlino), affiancandola nella seconda guerra mondiale a partire dal 1940. Promotore di politiche oppressive con forti connotazioni razziste antislave e finalizzate all'assimilazione delle minoranze interne ai confini italiani, nel 1938 il regime fascista promulgò le leggi razziali, che in parte ricalcarono la precedente normativa nazista.
Di fronte all'imminente sconfitta, il rovesciamento del regime con imprigionamento di Mussolini e il successivo armistizio (1943) provocarono la reazione dei tedeschi, che liberarono il Duce e lo posero a capo dello Stato fantoccio della Repubblica Sociale Italiana (RSI). Il Partito Fascista Repubblicano (PFR) accentuò i tratti totalitari del movimento sul modello nazista e tentò di riproporre i contenuti sociali delle origini con il manifesto di Verona. Nel contempo, le autorità fasciste collaborarono sempre più apertamente con i tedeschi nella caccia e lo sterminio degli ebrei. La RSI cadde con la fine dell'occupazione tedesca del Paese, sotto la spinta dell'offensiva alleata nella penisola e dell'insurrezione del 25 aprile 1945; alla caduta seguì la fucilazione di Mussolini per mano dei partigiani delle Brigate Garibaldi.
L'esperienza dello Stato fascista ufficialmente si estinse con la fine del secondo conflitto mondiale e fu ripudiata dalla Costituzione repubblicana, che assunse carattere antifascista e vietò la ricostituzione del partito alla XII disposizione transitoria e finale, attuata per via penale dalla Legge Scelba (1952). La disciplina ha interessato però solo di rado movimenti neofascisti sorti nel dopoguerra, poiché la sua applicabilità dipende dal carattere antidemocratico, violento o razzista del movimento[1] e per giurisprudenza dall'esistenza di un effettivo pericolo di ricostituzione immediata di un partito fascista.[2]
L'ideologia fascista, di cui Gentile e Mussolini elaborarono una sintesi dottrinaria nel 1932, non fu precostituita al movimento che, nelle parole di Mussolini stesso, fu improntato piuttosto a pragmatismo («Il fascismo non fu tenuto a balia da una dottrina elaborata in precedenza, a tavolino: nacque da un bisogno di azione e fu azione»). Il fascismo e la relativa dottrina sono complessi e oggetto di diverse interpretazioni, fermo restando il carattere antidemocratico, totalitario e violento del fascismo come movimento e regime.
Nella sua dimensione antibolscevica il fascismo incontrò all'inizio, se non approvazione, quanto meno acquiescenza anche presso regimi e personalità democratiche. Negli altri Paesi sorsero movimenti ispirati al fascismo italiano, che in certi casi presero il potere. Nonostante la somiglianza esteriore, tuttavia, non sempre l'emulazione produsse una piena aderenza ideologica o ricalcò l'insieme dei caratteri politici dell'esperienza fascista. Ciò non ha impedito che in senso estensivo si siano poi etichettati e si etichettino ancora come fascisti altri movimenti e regimi autoritari in Europa e nel mondo;[3] il termine fascismo ha connotazione spregiativa nel linguaggio politico, dove tende altresì a farsi generico e indiscriminato.[4]

Il fascismo prende il nome dai Fasci di combattimento fondati da Mussolini nel 1919,[5] che fanno a loro volta riferimento al fascio (in latino fascis) recato dagli antichi littori come simbolo del potere legittimo, e poi adottato da movimenti popolari e rivoluzionari come simbolo di unione dei cittadini, tanto da essere ancora incluso nei simboli e nelle panoplie di molti paesi ed entità subnazionali.
L'ascia legata al fascio simboleggiava lo ius vitae necisque, esercitato dalle massime magistrature romane; le verghe, usate materialmente dai littori per infliggere la pena della verberatio, l'ordinaria potestà sanzionatoria.
Il richiamo ai fasci è un esempio del fascino che il mito di Roma esercitava sul fascismo, che tentò una restaurazione dei fasti imperiali romani e giustificò la sua politica espansionistica come missione civilizzatrice del popolo italiano, erede di Roma antica.

La crisi economica del primo dopoguerra, la disoccupazione e l'inflazione crescenti, la smobilitazione dell'esercito che restituì alla vita civile milioni di persone, i conflitti sociali e gli scioperi nelle fabbriche del nord, l'avanzata del partito socialista divenuto il primo partito alle elezioni del 1919, crearono negli anni 1919-1922 le condizioni per un grave indebolimento delle strutture statali e per un crescente timore da parte dei ceti agrari e industriali di una rivoluzione comunista in Italia sul modello della rivoluzione d'ottobre del 1917. Il periodo tra le due guerre mondiali fu caratterizzato da forti tensioni sociali, soprattutto riguardo al reinserimento dei reduci della prima guerra mondiale e in particolare nel cosiddetto biennio rosso, che in Italia fu caratterizzato da una serie di lotte operaie e contadine che ebbero il loro culmine e la loro conclusione con l'occupazione delle fabbriche, soprattutto nel centro-nord del Paese.
Benito Mussolini, ex dirigente del Partito Socialista convertito alle idee del nazionalismo, riuscì a fondere idee, aspirazioni, frustrazioni dei reduci della Grande Guerra, in un movimento politico che all'inizio ebbe una chiara ispirazione socialista e rivoluzionaria, e che subito si contraddistinse per la violenza dei metodi impiegati contro gli oppositori. Il 23 marzo 1919 a Milano si radunarono circa trecento persone, soprattutto socialisti, sindacalisti, anarchici, ex-combattenti e in particolare arditi, intellettuali futuristi, che fondarono i Fasci italiani di combattimento.[6] L'intento era essenzialmente volto alla valorizzazione della vittoria sull'Austria-Ungheria e alla rivendicazione dei diritti degli ex-combattenti. Il primo fascismo contrapponeva i reduci, inviati al fronte, agli industriali che si erano arricchiti con l'industria bellica (definiti "pescecani"[7]). Dopo il primo congresso nazionale nel 1919, si presentarono alle elezioni politiche, ma senza ottenere alcun seggio. Nelle successive elezioni del 1921 vennero invece eletti 35 deputati.

Le violenze durante il periodo del biennio rosso perpetrate da arditi, futuristi e fascisti in un'offensiva contro sindacati e partiti d'ispirazione socialista causarono numerose vittime (circa tremila nel solo biennio 1921-22, secondo le stime di Gaetano Salvemini[8]) in particolare trecento morti fra i fascisti e quattrocento fra i socialisti[9] nella sostanziale indifferenza delle forze di polizia; la violenza crebbe considerevolmente negli anni 1920-22 fino alla marcia su Roma nel 1922. Sempre Salvemini sostenne che i tumulti e i propositi di "fare come in Russia" da parte dei socialisti massimalisti crearono una situazione di tensione:
Di fronte all'incalzare dello squadrismo fascista e dopo la marcia su Roma, il re Vittorio Emanuele III, preferendo evitare ulteriore spargimento di sangue e probabilmente meditando di poter sfruttare e controllare gli eventi, ignorò i suggerimenti di Luigi Facta, Presidente del Consiglio dei ministri in carica, che gli aveva chiesto di firmare il decreto che proclamasse lo stato d'assedio, e decise invece di conferire l'incarico di primo ministro a Mussolini stesso che guidò così un governo di coalizione composto da nazionalisti, liberali e popolari. Dopo il delitto Matteotti, il regime assunse connotazioni dittatoriali e si attuò la progressiva identificazione del partito con lo Stato; l'azione di governo favorì i ceti industriali e agrari con privatizzazioni, liberalizzazione degli affitti, smantellamento dei sindacati. Grazie poi alla legge Acerbo, una legge elettorale proporzionale con un grande premio di maggioranza, alle elezioni del 1924 il "listone fascista" ottenne uno straordinario successo, favorito da ingenti brogli, violenze, intimidazioni e rappresaglie contro gli oppositori.
L'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, che aveva denunciato in parlamento i brogli e chiesto l'annullamento delle elezioni, sembrò aprire la possibilità di una crisi del governo in quanto si diffuse la convinzione che i mandanti fossero ai vertici dell'esecutivo; l'episodio dimostrava che la "normalizzazione" dello squadrismo annunciata da Mussolini non era riuscita e che un'opposizione legale non era possibile. I partiti d'opposizione reagirono abbandonando il Parlamento, sperando che il Re intervenisse ma questi, intravedendo una sovranità monarchica liberata del contrappeso parlamentare, si astenne da ogni iniziativa. Successivamente il discorso di Benito Mussolini del 3 gennaio 1925, con il quale si assunse la responsabilità politica del delitto Matteotti e delle altre violenze squadriste, di fatto proclamò la dittatura, sopprimendo ogni residua libertà politica e di espressione e completando l'identificazione assoluta del Partito Nazionale Fascista con lo Stato. Seguì quindi la costituzionalizzazione del Gran Consiglio del Fascismo, nel 1928.[11] Pur assumendo alcune caratteristiche proprie dei regimi dittatoriali, il Fascismo si mantenne formalmente subordinato alla monarchia sabauda e fedele allo Statuto del Regno. Dal 1925 fino alla metà degli anni trenta il fascismo conobbe solo un'opposizione sotterranea e di carattere cospirativo, guidata da esponenti anarchici, comunisti, socialisti, demo-liberali, liberali, socialisti liberali, molti dei quali pagarono la loro opposizione al regime con la vita, l'esilio, la prigionia o il confino.
Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, Mussolini rimase in attesa degli eventi e inizialmente dichiarò l'Italia non belligerante. Quando, impressionato dalle facili e rapide vittorie della Germania e dall'imminente crollo della Francia, si convinse della vittoria dell'Asse, annunciò in un discorso a Roma il 10 giugno del 1940 l'entrata in guerra dell'Italia contro la Francia e l'Inghilterra,[12] dando nel contempo ordine ai comandi di mantenere un contegno difensivo verso la Francia.[13] L'impreparazione dell'esercito e l'incapacità dei comandanti condussero a terribili sconfitte su tutti i fronti, come nella campagna di Grecia nel 1940 e la rapida perdita dell'Africa Orientale Italiana (1941). Dopo una serie di alterne vicende nel tardo 1941 e nel 1942, la ritirata di Russia, nonché le sconfitte in Libia e Tunisia (1943), provocarono uno scollamento fra regime e popolo e il collasso degli apparati militari che aprì le porte all'invasione della Sicilia.
Il 25 luglio 1943 per iniziativa di alcuni gerarchi (Grandi, Bottai e Ciano) e con l'appoggio del Re, venne presentato un Ordine del giorno al Gran Consiglio del Fascismo col quale si chiedeva al Re di riprendere il potere; ciò portò all'arresto di Mussolini e all'improvviso crollo del regime, che si dissolse tra il giubilo di parte della popolazione italiana, stanca del regime e della guerra. L'esperienza bellica portò alla caduta del governo di Mussolini e al suo arresto e alla nomina del generale Badoglio come primo ministro. Con l'invasione degli Alleati, il paese era diviso in due, occupato dalle forze dell'Asse al nord e dagli Alleati al sud. Questa divisione consentì una temporanea rinascita del fascismo nelle regioni settentrionali, dove si organizzò la Repubblica Sociale Italiana, riconosciuta solo dai paesi dell'Asse. Negli ultimi venti mesi di esistenza il fascismo fu coinvolto nella guerra civile con le formazioni partigiane che fiancheggiavano l'avanzata alleata, nonché dall'attiva collaborazione con la politica tedesca di deportazione, concentramento e sterminio degli ebrei e di altre minoranze.[14] Alla fine di aprile 1945 con il crollo del fronte e l'insurrezione popolare proclamata per il giorno 25 dal Comitato di Liberazione Nazionale, la RSI fu spazzata via. I suoi elementi dirigenti, compreso Mussolini, furono catturati dai partigiani e fucilati fra 28 e 29 aprile 1945. Con la morte di Benito Mussolini l'esperienza fascista si concluse.
Quando in Italia il partito fascista giunse al potere, nel resto dell'Europa (comprese Francia e Regno Unito) e del mondo non si guardò a esso con sfavore, soprattutto per il suo impegno come argine al bolscevismo sovietico e l'eversione. In seguito, durante il periodo di massimo consenso del regime, fra 1925 e 1935, il miglioramento dell'immagine dell'Italia nel mondo portò perfino diverse personalità del pensiero democratico (fra cui Winston Churchill[15] e il Mahatma Gandhi)[16] a esprimere simpatia per Mussolini e il suo regime. D'altro canto l'esperienza fascista non mancò di provocare in Europa (e non solo) movimenti fascisti e filofascisti di emulazione, per lo più ideologica e di immagine.
Nella maggioranza di questi casi, infatti, la somiglianza col fascismo italiano è solo epidermica, legata a certi stilemi (saluto romano, colore scuro delle camicie, manifestazioni di massa etc.), al culto del capo e della violenza, e a un feroce anticomunismo. In altri casi si verificarono anche "gemellaggi" con la dottrina sociale, filosofica e politica vera e propria. Il più famoso dei movimenti para-fascisti fu il NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei o Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori) di Adolf Hitler. Nel resto d'Europa, furono molti i movimenti fascisti e filofascisti che si svilupparono e, soprattutto nell'Europa orientale, salirono anche al potere.

D'ispirazione sindacal-corporativa, militante,[17] socialista revisionista[18] e organicista,[19] il fascismo raggiunse il potere nel 1922, dopo la grande guerra con la Marcia su Roma[20] e si costituì in dittatura nel 1925. Il fascismo descrive se stesso come una terza via alternativa a capitalismo liberale e comunismo marxista, basata su una visione interclassista, corporativista e totalitaria dello Stato, contraria alla democrazia di massa. Radicalmente e violentemente contrapposto al comunismo[21], il fascismo rifiuta infatti anche i principi della democrazia liberale, pur riconoscendo la proprietà privata. Appare inoltre come un movimento tradizionalista e spiritualista in alcune componenti, in altre mostra una chiara ascendenza positivistica.[22] All'elaborazione della dottrina fascista, oltre che Mussolini, contribuì il filosofo idealista Giovanni Gentile.
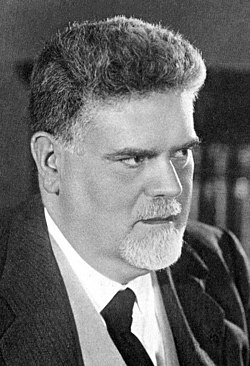
I testi teorici fondamentali del fascismo sono essenzialmente due: il Manifesto degli intellettuali fascisti e La dottrina del fascismo. Gentile pubblicò il 21 aprile 1925 il Manifesto degli intellettuali fascisti agli intellettuali di tutte le Nazioni e, insieme a Mussolini, lo scritto La dottrina del Fascismo (1933). Il 1º maggio del 1925, il filosofo Benedetto Croce, inizialmente favorevole al fascismo, pubblicò il Manifesto degli intellettuali antifascisti che ebbe tra i firmatari molti altri intellettuali. Importante anche la voce "fascismo" dell'Enciclopedia italiana, scritta da Mussolini con Gioacchino Volpe. Nel fascismo è presente anche l'influenza di Friedrich Nietzsche, tramite l'interpretazione teorica e pratica data da D'Annunzio, di Georges Sorel e del futurismo di Marinetti. Nietzsche fu l'unico filosofo che Mussolini studiò veramente, dal quale in gioventù fu ammaliato e dalla cui dottrina del superuomo egli trasse il senso da dare alla rivoluzione fascista.[23]
Un fondamentale contributo alla nascita del fascismo fu dato dal movimento dello Squadrismo, ossia l'organizzazione di squadre paramilitari con le quali si realizzò una sistematica demolizione di sedi di partito (socialisti, popolari, comunisti) e di giornali, cooperative, case del popolo e la progressiva occupazione - con mezzi legalitari e illegali - di posizioni chiave nelle amministrazioni comunali. Inoltre lo stesso Giovanni Giolitti tenne nei confronti del movimento fascista un atteggiamento benevolo volto a utilizzarlo nel contrastare la sinistra[24] in quanto era poi intenzionato a "costituzionalizzarlo" dopo essere arrivato al potere. Così facendo si riteneva di esaurirne le potenzialità poiché, essendo venuti meno gli avversari di sinistra, il fascismo avrebbe conseguentemente perso gli appoggi, anche finanziari, di coloro che temevano la "minaccia rossa"[25].
Secondo l'ideologia fascista, una nazione sarebbe una comunità che richiede dirigenza forte, identità collettiva e la volontà e capacità di esercitare la violenza per mantenersi vitale.[26][27] Per l'ideologia fascista la cultura è creata dalla società nazionale collettiva, dando luogo a un rifiuto dell'individualismo;[26] il fascismo nega inoltre l'autonomia di gruppi culturali o etnici che non sono considerati parte della nazione fascista e che rifiutano di essere assimilati: questo in tutte le realizzazioni storiche del fascismo è stato applicato nei confronti di minoranze etniche o religiose, in particolare quella ebraica.[28] L'ideologia fascista sostiene l'idea di uno Stato a partito unico[29] e vieta qualunque opposizione al partito stesso.[30]
Nacque principalmente come reazione alla Rivoluzione Bolscevica del 1917 e alle lotte sindacali, operaie e bracciantili, culminate nel Biennio rosso[31], ma al tempo stesso in parziale polemica con la società liberal-democratica uscita lacerata dall'esperienza della prima guerra mondiale,[32] unendo aspetti ideologici tipici dell'estrema destra (nazionalismo, militarismo, espansionismo) con quelli dell'estrema sinistra (primato del lavoro, rivoluzione sociale e generazionale, sindacalismo rivoluzionario soreliano), inserendovi elementi ideali originali e non, quali l'aristocrazia dei lavoratori e dei combattenti, la concordia fra le classi (organicismo),[33] il primato dei doveri dell'uomo sui diritti (mediato dal pensiero di Giuseppe Mazzini[34]), e il principio gerarchico, assorbito dal fascismo dall'esperienza dei reparti d'assalto volontari della divisione Arditi della Grande Guerra, che lo portarono al culmine dell'obbedienza cieca e pronta al capo. Si riporta qui la definizione di fascismo data, nel 1921, da colui che ne fu l'ideatore e il capo, Benito Mussolini:
Il giornalista, politico e antifascista Piero Gobetti nel 1922, riconduceva il fascismo alla tendenza all'autoritarismo tipica della cultura italiana, che a suo parere rifugge dal confronto delle idee e predilige invece la disciplina dello Stato forte:
Fra le innumerevoli interpretazioni successive del fascismo si riportano le seguenti di Lelio Basso (1961):
Quella recente (2002) dello storico Emilio Gentile fu invece la seguente:
Da ultimo, è importante sottolineare come il fascismo fu sempre considerato dai suoi aderenti un movimento rivoluzionario[senza fonte], trasgressivo e ribelle (emblematico in tal senso il motto «me ne frego») in radicale contrasto col liberalismo dell'Italia pre-fascista. Pur avendo all'inizio tutelato gli interessi della borghesia industriale, Mussolini respinse ogni ipotesi di collusione con essa. Emblematico di ciò fu il cosiddetto programma di socializzazione dell'economia, tentata durante l'esperienza della Repubblica Sociale Italiana.
Nel corso dei due decenni di governo, detti ventennio, il fascismo cercherà anche di imporre la propria visione antropologica al popolo italiano attraverso politiche educative, culturali, eugenetiche e infine attraverso una legislazione razzista e antisemita. In politica estera, il regime promuoverà prima una blanda revisione dei trattati di pace del 1919 per assicurare contemporaneamente una maggiore forza all'Italia e la stabilità in Europa, ma in seguito al sorgere del nazismo in Germania a metà degli anni trenta, il regime compì una spirale di scelte tali che nel suo ultimo quinquennio il fascismo finì col legarsi sempre più al regime nazista, con il quale finirà coinvolto nella seconda guerra mondiale. In seguito alla crisi del 1924-25 il regime fascista - fino ad allora al governo in maniera statutaria - subirà una svolta autoritaria che porterà all'abolizione delle libertà democratiche e alla realizzazione di una dittatura autoritaria. Il potere relativamente ampio del regime mussoliniano, ottenuto tramite la soppressione poliziesca dell'opposizione politico-partitica, consentirà al fascismo di imprimere radicali modifiche al paese, alla sua società, alla sua cultura e alla sua struttura economica.
L'esperienza bellica sarà disastrosa per il regime e per il paese. Le sconfitte sui fronti d'Africa e Russia con la conseguente invasione alleata delle regioni meridionali italiane portò alla caduta del governo di Mussolini e al suo arresto e la nomina del generale Badoglio come primo ministro: in una sola giornata venti anni di regime vennero spazzati via e quindi a una divisione della penisola in due tronconi, occupati rispettivamente dalle forze dell'Asse al nord e Alleati al sud. Questa divisione consentì una temporanea rinascita del fascismo nelle regioni settentrionali, dove esso organizzò uno Stato di fatto (Repubblica Sociale Italiana, RSI) riconosciuto solo dai paesi dell'Asse. Negli ultimi venti mesi di esistenza il fascismo fu coinvolto nella guerra civile con le formazioni partigiane che fiancheggiavano l'avanzata alleata. Alla fine di aprile 1945 con il crollo del fronte e l'insurrezione popolare proclamata per il giorno 25 dal Comitato di Liberazione Nazionale, la RSI fu spazzata via. I suoi elementi dirigenti - compreso Mussolini - catturati dai partigiani, furono fucilati fra 28 e 29 aprile 1945. Con la morte di Benito Mussolini l'esperienza fascista può essere considerata conclusa.
Lo storico Federico Chabod[38] evidenzia le cause fondamentali dell'ascesa del fascismo: la complessa e conflittuale situazione politica con il benevolo atteggiamento di Giolitti verso i fascisti e i contrasti interni al partito socialista diviso tra riformismo e massimalismo nonché i contrasti tra cattolici e socialisti; il mito della vittoria mutilata nato alla fine della prima guerra mondiale; l'inflazione della moneta; l'aumento delle tasse e dei prezzi; la disoccupazione diffusa che riguardava anche gli ex combattenti; il problema della riconversione industriale da industria bellica a industria di pace; la rovina economica delle classi medio e piccolo-borghesi; i facili arricchimenti di guerra; i grandi proprietari fondiari e gli industriali che temevano l'avvento di un bolscevismo italiano e vedevano con sgomento l'occupazione delle terre e delle fabbriche, gli scioperi, le agitazioni operaie, ed erano quindi pronti ad appoggiare le squadre fasciste per tutelare i propri interessi. Ha scritto testualmente lo Chabod:[39]"Tutto questo determinò un profondo sconvolgimento che colpì tutti gli interessi e offese tutti i sentimenti. Interessi colpiti: piccoli borghesi che cadono nelle ristrettezze economiche, grandi proprietari fondiari che cominciano a temere l'avvento del bolscevismo italiano e vedono con sgomento l'occupazione delle terre, gli scioperi, le agitazioni operaie, l'occupazione delle fabbriche. Sentimenti offesi: l'amor di patria negato da socialisti e comunisti, la delusione dei trattati di pace, il mito della vittoria mutilata, la vana attesa delle masse della pace e della giustizia, il disordine e l'anarchia ogni giorno crescenti, la paura e l'incubo della rivoluzione sociale."
In queste circostanze il fascismo, che propugnava la necessità di uno Stato forte e totalitario, l'esigenza dell'ordine e del rispetto della proprietà, la lotta al bolscevismo, apparve come una concreta possibilità di salvezza alla borghesia, sia dal punto di vista economico sia da quello ideologico. "Agrari e industriali, reagendo al movimento proletario, appoggiarono il fascismo; se gli uni non volevano sentire parlare di terre ai contadini e dell'imponibile della mano d'opera, gli altri non accettavano il controllo operaio sulle fabbriche. Il loro appoggio finanziario al fascismo è fuori discussione".[40] Lo Chabod evidenzia inoltre l'errore commesso dal Giolitti: "L'errore fondamentale del Giolitti fu di valutazione: giudicò il fascismo in base alle vecchie formule della lotta politica e parlamentare, credette ancora alla possibilità di blandirlo, di servirsene, di affidargli la parte di aiutante, salvo a sbarazzarsene in seguito".[41] Le squadre, che, a detta di Mussolini, giunsero a raccogliere 300.000 aderenti,[42] fornirono il nerbo della forza eversiva con la quale, il 28 ottobre 1922 il Fascismo marciò su Roma convincendo il sovrano Vittorio Emanuele III a consegnare le redini del governo.
Con il congresso di Roma del 9 novembre 1921 il fascismo si trasformò da movimento in partito. In seguito alla marcia su Roma del 28 ottobre del 1922, il re Vittorio Emanuele III incaricò Benito Mussolini di formare un nuovo governo. Mussolini si presentò alle Camere con un governo di coalizione formato soprattutto da esponenti liberali, cattolici e da alcuni esponenti moderati dal Partito Fascista, e ottenne la fiducia il 30 ottobre del 1922. Il programma politico aveva subito una serie di aggiustamenti con l'obiettivo di favorire gli abboccamenti con le forze conservatrici e reazionarie, le quali cominciarono quasi subito a finanziare il movimento.[43]
Con l'arrivo al potere, Mussolini intraprese una politica di riassetto delle casse dello Stato, di liberalizzazioni e riduzioni della spesa pubblica. Venne riformata la scuola dietro impulso del filosofo Giovanni Gentile. D'altro canto diede seguito a una serie di rivendicazioni delle associazioni combattentistiche, e dei sindacati fascisti, garantendo le pensioni e le indennità ai reduci e ai mutilati e rendendo obbligatoria la giornata lavorativa di otto ore agli operai. In politica estera, l'Italia accettò i patti siglati a Locarno con la Jugoslavia, ma ebbe la protezione delle minoranze italiane in Dalmazia e l'autonomia di Fiume (che nel 1924 venne unita all'Italia). Infine ci fu anche la revisione - a favore dell'Italia - dei confini delle colonie (fu rettificato il confine di Tripolitania e Cirenaica ed esteso il Fezzan ad alcune oasi strategiche, e alla Somalia venne annesso l'Oltregiuba).[44]
La presenza tuttavia di un'ala oltranzista nel PNF, rappresentata da elementi estremisti come Italo Balbo e Roberto Farinacci, impedì la "normalizzazione" delle squadre d'azione, che continuarono a imperversare nel paese spesso fuori da ogni controllo.[senza fonte] Ne fecero le spese numerosi antifascisti, il più importante dei quali, Giacomo Matteotti, che accusò in Parlamento Mussolini di aver vinto grazie a brogli elettorali, venne assassinato il 10 giugno 1924 nel corso del suo rapimento da parte di una banda di squadristi capeggiata da Amerigo Dumini.
La cosiddetta "crisi Matteotti" che ne seguì mise il governo Mussolini di fronte a un bivio: continuare a governare in modo legalitario, rispettando quantomeno nella forma lo Statuto, oppure imprimere una svolta autoritaria. Mussolini, premuto dai ras dello squadrismo, optò per la seconda scelta. Il fascismo divenne dunque dittatura.[45] I passaggi successivi con cui il governo Mussolini si trasforma in dittatura sono i seguenti (per approfondire, vedi anche leggi fascistissime):
Durante il fascismo, la lotta alla mafia venne affidata a Cesare Mori, ricordato come il "prefetto di ferro", inviato nell'isola nel maggio del 1924, dove condusse una dura repressione delle attività criminose di Cosa nostra in Sicilia. In questo periodo venne arrestato il boss Vito Cascio Ferro. Dopo alcuni arresti eclatanti di capimafia, i vertici di Cosa nostra non si sentivano più al sicuro e scelsero due vie per salvarsi: una parte emigrò negli USA, entrando nella Cosa nostra statunitense, mentre un'altra restò in disparte. Il "prefetto di ferro" coinvolse anche personalità di spicco del PNF come Alfredo Cucco, che fu espulso dal partito. Nel 1928 Mori fu nominato senatore e nel 1929 collocato a riposo.Nel 1932, nel centro di Canicattì, avvengono tre omicidi, altri a Partinico associati incendi, danneggiamenti in stile mafioso; e eventi delittuosi dei quali la stampa non parla, cui il regime risponde con «qualche condanna alla fucilazione e con una nuova ondata di invii al confino». Nel 1937, Genovese venne accusato di aver ordinato l'omicidio del gangster Ferdinando "Fred" Boccia, che era stato assassinato perché aveva preteso per sé una grossa somma che lui e Genovese, barando al gioco, avevano sottratto ad un commerciante[48]; per evitare il processo, Genovese fuggì in Italia, dove si stabilì a Nola. Nel giro di poco tempo giunse a legarsi ad alcuni gerarchi fascisti, tanto da finanziare anche la costruzione di una Casa del Fascio a Nola[49]. Si presume, inoltre, che fosse lui a rifornire abitualmente di cocaina il gerarca Galeazzo Ciano, genero di Mussolini.[50] [51] Alcuni mafiosi erano membri del PNF, a conoscenza e con il favore di Benito Mussolini. Il principe Lanza di Scalea fu uno dei candidati nelle liste del PNF per le amministrative di Palermo mentre a Gangi il barone Antonio Li Destri,[52] pure candidato del PNF, era protettore di banditi e delinquenti.La mafia ridarà segni di vita prima dello sbarco alleato del luglio 1943.
La mano ferma contro la criminalità agli inizi era servita al fascismo per affermarsi. Centinaia di delinquenti, piccoli e grandi, vennero inviati al confino. L'obiettivo era duplice: arrestare i camorristi scomodi, restii ai patti con la polizia, e dare all'opinione pubblica dimostrazione di una mano ferma contro la criminalità, legando ancora di più al regime i delinquenti più morbidi[46].
Mussolini concesse la grazia a diversi condannati per reati legati alla criminalità organizzata, convinto che, nel nuovo contesto dittatoriale, questi individui non avrebbero più costituito un pericolo.[53] Alcuni ex delinquenti furono integrati nelle squadre fasciste, talvolta beneficiando di una certa tolleranza nei confronti del loro passato criminale.[46]
Negli anni successivi alla nascita del fascismo, a Napoli si svilupparono tensioni tra diverse correnti interne al partito, come il movimentismo di Aurelio Padovani e le tendenze istituzionali di Paolo Greco. In questo contesto, in alcuni quartieri si osservò la partecipazione di individui legati alla malavita locale all’organizzazione delle squadre fasciste e al controllo dei sindacati padronali.[54]
In particolare, alcuni camorristi locali furono coinvolti nell’attività di sorveglianza e repressione di attività considerate sovversive. Nel contesto della crescita fascista, personaggi come Arturo Cocco e Salvatore Cinicola assunsero ruoli di intermediazione tra la polizia e i quartieri di origine, mentre altri furono impiegati in operazioni di controllo nelle fabbriche e nei porti, come i fratelli Vittorio e Armando Aubry a Bagnoli.[46]
A partire dalla metà degli anni trenta, il regime fascista avviò una politica più rigorosa nei confronti della criminalità organizzata, con invii al confino di centinaia di individui considerati pericolosi o non collaborativi.[55]
Il fascismo si caratterizzò come un movimento nazionalista, autoritario, autocratico, razzista, anticomunista e totalitario; l'ideologia sottesa a tale movimento fu interpretata allo stesso tempo come rivoluzionaria[56] e reazionaria;[57] in particolare il fascismo si autodefiniva,[58] nonché fu considerato da vari politologi e studiosi, come alternativo al capitalismo liberale, proponendo una terza via.[59][60] Sul piano ideologico fu populista,[61] collettivista,[62][63][64] statalista,[65][66][67][68][69][70] fautore della funzione sociale della proprietà privata e della divisione della società in classi[71] e del rifiuto del liberalismo e della democrazia.
Trovò i suoi precursori, negli anni precedenti alla prima guerra mondiale, nel movimento artistico del futurismo (il cui ispiratore, Filippo Tommaso Marinetti, aderì poi al movimento di Mussolini), nel decadentismo di D'Annunzio e in numerosi altri intellettuali nazionalisti che si ritrovarono nella rivista Il Regno (Giuseppe Prezzolini, Luigi Federzoni, Giovanni Papini), molti dei quali militarono in seguito nelle file fasciste. Importante fu anche il contributo di correnti di pensiero quali il sindacalismo rivoluzionario, ispirato alle idee di Georges Sorel.
Una spinta decisiva alla nascita del fascismo venne anche dalle componenti, prodotte dalla prima guerra mondiale, dell'arditismo e del reducismo. La critica storica di alcuni studiosi come Piero Calamandrei o Paolo Alatri esita tuttavia ad attribuire una base ideologica al movimento fascista connotato, specie fra il 1920 e il 1924, da diverse filosofie operative, con repentini e opportunistici cambiamenti di impostazione politica tali da negare di per se stessi l'esistenza di una dottrina unitaria del movimento prima e del partito poi.[72]
Sebbene il fascismo sia nato come movimento politico filosoficamente a carattere prettamente idealista,[73] anti-ideologico[74] e pragmatico,[75] storicamente si è estrinsecato in una serie di posizioni, di volta in volta supportate da un'ampia e reboante propaganda, apparentemente contraddittorie - se non incoerenti - fra loro. Per tale motivo, nell'analizzare il fenomeno fascismo occorre scindere il fascismo "ideale" da quello "reale" esattamente come si fa per il marxismo, considerando che il modus operandi del fascismo storico fu dettato dalle circostanze tanto quanto dall'ideologia e dalla filosofia, e che a circostanze diverse la medesima ideologia è stata cambiata e piegata dalla filosofia originaria del movimento.[76]
Nel saggio La dottrina del fascismo pubblicato nel 1932 viene fatta un'esposizione sistematica del pensiero fascista. Nella dottrina del fascismo il movimento si percepisce come nazionalista, il cui obiettivo finale è "una più grande Italia".[77] Secondo i pensatori fascisti e lo stesso Mussolini, questo obiettivo si inquadra in una visione della storia di tipo conflittuale, nella quale società a base più o meno nazionale si incontrano, concorrono fra loro e - se necessario - si scontrano. E - per necessità darwiniana - in questo scontro sopravvivono solo le nazioni compatte al proprio interno, da cui discende la necessità di trovare una sintesi hegeliana della lotta di classe e delle esigenze dello Stato, tramite l'obbligo per ciascun cittadino (prestatore d'opera o capitalista) a concorrere a una concordia nazionale nel nome della produzione (industriale, agricola, bellica, etc., fonte di ricchezza per l'intera comunità nazionale e di potenza per lo Stato).
All'origine del movimento vi è l'idea mussoliniana della nascita, nelle trincee della grande guerra e nelle fabbriche della produzione bellica, di una nuova aristocrazia dei combattenti (trincerocrazia) e dei lavoratori che realizzi, appunto, "la sintesi dell'antitesi classe-nazione".
La concordia interna al paese viene sostenuta con argomentazioni organiciste e con l'affermazione metafisica che la Nazione è più della somma dei singoli individui che l'abitano, bensì "un organismo comprendente la serie indefinita delle generazioni di cui i singoli sono elementi transeunti". Per la qual cosa, i viventi sono impegnati da un obbligo di riconoscenza verso le generazioni che li hanno preceduti e da un obbligo a lasciare un paese migliore alle generazioni che seguiranno. Cardine fondamentale della filosofia fascista è l'assoluta preminenza dello Stato e tramite questo del partito fascista (che se ne considerava al servizio), in ogni aspetto della vita politica e sociale. In questo senso il fascismo si pone come un movimento politico di stampo neohegeliano propugnando lo stato etico. Organicismo e stato etico hanno come conclusione logica la proclamazione del totalitarismo, nel IV Congresso del PNF (1925) per voce dello stesso Mussolini. Lo Stato totalitario avoca a sé tutte le prerogative e i diritti e pervade in maniera "totalitaria", appunto, le esistenze dei suoi cittadini. La concezione fascista dell'uomo prevede la negazione del cosiddetto homo oeconomicus, visione che gli ideologi fascisti sostengono accomuni liberalismo e marxismo, per proporre una visione differente.
Il fascismo è filosoficamente debitore di due opposte e differenti correnti di pensiero ottocentesche: da un lato vi è una corrente, ispirata a personaggi come Sorel, Proudhon, Corridoni e ai Futuristi, che propugnavano la rivoluzione, il sindacalismo combattente, l'ascesa della violenza come irrazionale ma decisiva soluzione ai problemi e alle aporie della logica e della democrazia liberale.[78]
Dall'altro lato si riallaccia a correnti di pensiero ultraconservatrici, che risalgono al XIX secolo, in generale contraddistinte dalla critica contro il materialismo e l'idea di progresso delle società capitaliste borghesi, ritenute distruttrici dei valori più profondi della civiltà europea. Tali scuole di pensiero tendono a rievocare un'idea romantica, di una mitica società premoderna, armonica e ordinata, nella quale i diversi ceti della società, ciascuno nel suo ambito, collaborano per il bene comune[79]. Da questo promana la critica alla democrazia liberale e alla società di massa "che avvilisce l'uomo" (il numero contro la qualità), fino a giungere a pensatori che sul finire del XIX secolo e l'inizio del XX secolo ritenevano esaurita la funzione della civiltà occidentale (in particolare Oswald Spengler, autore del famoso saggio Il tramonto dell'Occidente). Infine, non meno importante, soprattutto in Mussolini, è l'influenza del pensiero di Nietzsche, che - sebbene sommamente impolitico - permea continuamente il modus cogitandi del capo del fascismo.[80]
Sebbene il fascismo si proclamasse anti-ideologico, un'ideologia del fascismo fu elaborata negli anni venti e successivamente stilata in un articolo scritto da Giovanni Gentile[81] durante il suo incarico di Ministro della pubblica istruzione e poi siglato da Mussolini, che però venne applicata solo in parte. In particolare essa non fu mai rigidamente codificata, sebbene abbondassero durante tutto il ventennio le "volgarizzazioni" e i "catechismi", che ebbero più che altro funzione propagandistica verso il popolo minuto. In pratica, però, nell'élite dirigente e intellettuale del Regime si dibatté aspramente sui vari indirizzi da dare alla politica italiana, e il fascismo oscillò spesso fra posizioni diversissime e contraddittorie.[82]
Fra gli aspetti ideologici del fascismo che occorre citare, vi sono i seguenti:
In particolare quest'ultimo addentellato divenne sempre più importante nel fascismo a partire dalla grande crisi del 1929, tanto da poter essere considerato più un aspetto genetico del fascismo che non semplicemente ideologico.
Fondamentalmente il fascismo rifiuta la democrazia; esso non considera sé stesso un'esigenza temporanea, ma un sistema politico a sé stante a tutti gli effetti: la "terza via" contrapposta tanto alla destra reazionaria quanto alla sinistra marxista.
Il fascismo sostiene che le "autoproclamatesi" democrazie siano in realtà effettivamente regimi plutocratici, sorta di dittature massoniche basate sulla manipolazione della volontà popolare.
Questa considerazione viene da un aspetto dell'origine del fascismo, che è riassunta nel famoso discorso di Benito Mussolini nella frase:
Il fascismo secondo il suo fondatore avrebbe dovuto rappresentare una forma di governo al di sopra delle divergenti opinioni dei partiti.
Nella sua fase finale il fascismo rifiutò poi le elezioni sul modello dei regimi democratici liberali dell'epoca (definendoli Ludi cartacei) ideando la democrazia organica, che ebbe una sperimentazione parziale poi nella Spagna franchista e nel Portogallo.
Assumono carattere totalitario così sia le leggi che hanno provveduto a eliminare (o "fascistizzare") le libertà liberali quali quelle di associazione, di stampa, di espressione etc., sia le leggi cosiddette "fascistissime", ossia:
Queste leggi – altrimenti tipiche di qualunque autoritarismo – considerate nel contesto organico dello sviluppo del fascismo, permettono di approfondire ulteriormente i caratteri totalitari del fascismo, ossia:
Altro aspetto totalitario del regime si trova nella volontà appunto "totalitaria" di costringere ogni cittadino nell'ambito di un organismo collettivo (il cosiddetto "Armonico Collettivo"); l'individuo viene così inserito forzatamente, a prescindere dalla sua volontà, all'interno di strutture di partito le quali si occupano di "integrarlo" e inquadrarlo "dalla culla alla tomba" in formazioni educative, paramilitari, politiche, culturali, sindacali, corporative e assistenziali.
Accanto alle organizzazioni di partito, il fascismo intese anche dominare i mezzi di comunicazione di massa, avendo intuito Mussolini che il controllo capillare di stampa, radio e cinema era "l'arma più forte" per facilitare la trasmutazione fascista della società italiana; vi fu quindi un controllo rigoroso della circolazione delle informazioni sia attraverso il monopolio statale dei mezzi di informazione di massa (giornali, cinegiornali e radio), sia attraverso il controllo e l'uso della censura preventiva sugli altri mezzi di comunicazione di massa (teatro, cinema, musica leggera, fumetti) culminato nel 1939 con l'estensione del visto di censura preventivo anche per le opere musicali.
Ulteriore carattere totalitario del regime fu il costante uso della violenza e della repressione - oltre che il costante richiamo all'odio, al disprezzo e alla denigrazione - verso i partiti e i movimenti antifascisti o antinazionali (comunisti, neutralisti, bolscevichi, pacifisti, democratici)[86], teso a imporre l'idea fascista su quelle dei suoi nemici (fin dall'inizio), nonché (dal 1938) verso gli ebrei, tramite l'approvazione dei provvedimenti di segregazione razziale. Alla luce di questi elementi, il fascismo inteso come forma di stato "totalitaria" si contraddistingue per la presenza di un partito unico che pervade la società in ogni suo aspetto, tramite un'incisiva e mirata propaganda tesa a imporre il volere del partito unico a ogni individuo, e tramite l'uso delle forze di polizia e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale[87] atte a scoraggiare qualsiasi atto contrario al regime, nonché con l'identificazione di un "nemico" da additare al popolo (comunisti, partiti antifascisti, democratici, pacifisti, e dal 1938 anche ebrei).

La volontà del fascismo di incidere nella storia si manifestò anche con l'istituzione della cosiddetta era fascista, ossia una particolare numerazione degli anni che faceva riferimento al giorno della marcia su Roma. Il primo anno dell'Era fascista era considerato dal 29 ottobre 1922 al 28 ottobre 1923. Il calendario in uso rimaneva quello gregoriano, mentre venivano indicati in maniera diversa solo gli anni. In genere, era adottata una doppia numerazione: in cifre arabe l'anno secondo l'Era cristiana e in numeri romani quello secondo l'Era fascista.
L'indicazione dell'introduzione dell'era fascista risulta da una circolare del 25 dicembre 1926 emanata da Benito Mussolini come capo del Governo.[88] L'origine viene però ricondotta a una richiesta presentata il 26 novembre 1926 da Pietro Fedele, ministro della pubblica istruzione.[89]
L'anno era considerato a partire dal 29 ottobre di ogni anno (giorno successivo alla marcia su Roma)[90][91] per terminare il 28 ottobre dell'anno successivo.
Il sistema di datazione fu interrotto dal 26 luglio 1943 con la caduta del Governo Mussolini; fu ripreso dalla Repubblica Sociale Italiana tra il 15 settembre 1943 e il 28 aprile 1945.[92]
Pochi punti fermi dell'ideologia fascista furono sempre rispettati, cambiando di volta in volta la politica contingente, attraverso una visione pragmatica quando non cinica: fra essi, il principio di "una più grande Italia"; il principio del "primato del duce"; il principio dei "doveri dell'uomo". Tutto il resto, dalla politica economica (di volta in volta liberista nel suo primo periodo, statalista dopo la crisi del 1929, infine velleitariamente socializzatrice[93] durante il periodo repubblicano) a quella estera (con le alleanze oscillanti, l'anticomunismo accompagnato dal riconoscimento dell'URSS), a quella militare (militarismo per le masse, accompagnato da una progressiva riduzione delle spese per le Forze Armate[94]), fu di volta in volta determinato dalle direttive mussoliniane.

Il fascismo visse infatti soprattutto della volontà di Mussolini e si limitò a seguire alcuni principi di massima da lui indicati di volta in volta. Inoltre questo portò ad alimentare il culto della personalità, adoperando i mezzi di comunicazione di massa per trasmettere un ideale di uomo forte, deciso e risoluto: un fenomeno che ha preso il nome di "mussolinismo".
Il Manifesto degli intellettuali fascisti, pubblicato il 30 marzo 1925 fu il primo documento ideologico della parte della cultura italiana che aderì al regime fascista e il tentativo di indicare le basi politico-culturali dell'ideologia fascista. Anche la letteratura italiana durante il fascismo fu influenzata dal regime.
L'Istituto Nazionale di Cultura Fascista (INCF) fu fondato nel dicembre 1925 e preposto alla diffusione e allo sviluppo degli ideali fascisti e della cultura italiana. Fu alle dirette dipendenze del Segretario del Partito e fu sottoposto all'alta vigilanza di Mussolini.
Sempre nel 1925 nasce l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana a opera di Giovanni Treccani e Calogero Tumminelli, con direttore scientifico il filosofo Giovanni Gentile. Le sue principali opere furono dal 1929 l'Enciclopedia Italiana diretta da Gentile e nel 1940 il Dizionario di politica, diretto dal filosofo del linguaggio Antonino Pagliaro. Nel 1926 fu fondata la Reale Accademia d'Italia con il compito di "promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti". Prese il via nel 1929. Dopo il Manifesto degli intellettuali fascisti del '25, Mussolini e Gentile firmarono la voce fascismo dell'Enciclopedia Italiana, definita un "centone pragmatista" da Federzoni.[95]

La Scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, fondata nel 1930 a Milano da Niccolò Giani e da Arnaldo Mussolini, si proponeva in particolare di essere il centro di formazione politica dei futuri dirigenti del Fascismo. I principi-chiave sui quali l'insegnamento si basava erano l'attivismo volontaristico, la fede nell'Italia dalla quale si riteneva derivasse quella in Benito Mussolini e nel Fascismo, l'anti-razionalismo, un certo connubio tra religione e politica, la polemica con la liberal-democrazia e il socialismo, il culto della "romanità".
I Littoriali dello Sport, della Cultura e dell'Arte e del Lavoro erano manifestazioni culturali, artistiche e sportive destinate ai migliori universitari dei GUF, svoltesi in Italia tra il 1932 e il 1940[96]. Erano organizzati dalla Segreteria nazionale del Partito Nazionale Fascista.
Alla fine degli anni trenta il fascismo cominciò a elaborare una serie di teorie razziste e antisemite, in parte a imitazione di ciò che stava avvenendo parallelamente in Germania. Nell'autunno 1938, nel quadro di una grande azione razzista già tempo prima, il governo Mussolini varò la "normativa antiebraica sui beni e sul lavoro", ossia la spoliazione dei beni mobili e immobili degli ebrei residenti in Italia.[97] In seguito a una feroce campagna di stampa (in parte pagata segretamente da agenti tedeschi incaricati da Goebbels)[98] si giunse ad approvare in fasi successive delle leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei e delle popolazioni non indoeuropee delle colonie[99]. In queste ultime si puntò alla realizzazione di una sorta di sviluppo separato (apartheid) del genere praticato in quel periodo già in alcune colonie britanniche e negli Stati del sud degli Stati Uniti. In seguito i provvedimenti discriminatori[100] si estesero anche ai cittadini italiani e libici di religione israelita, con un progressivo allontanamento della maggioranza di essi dalla vita pubblica italiana nonché con l'internamento in vari campi di concentramento fascisti.
Venne anche promulgato un Manifesto della razza, nella stesura del quale oltre a nomi dell'Accademia d'Italia vi era anche la mano di Mussolini. Nel 1938 Benito Mussolini espose il suo pensiero circa la questione razziale in questa maniera:
Mussolini, in merito all'insorgere di una questione ebraica per il fascismo, poi, così proseguiva:
Il razzismo fascista prese varie forme, nel tentativo di distinguersi da quello nazista[101], e in esso convissero sia la convinzione del razzismo biologico sia quella del razzismo spirituale,[102] invece generalmente assente nei razzismi nazista e in quelli di altri paesi. Un importante contributo all'antisemitismo fascista venne anche da taluni ambienti cattolici, sebbene il Vaticano non abbia mai né approvato, né appoggiato ufficialmente i provvedimenti antisemiti. Nessun documento proverebbe invece pressioni ufficiali e dirette da parte tedesca[103] durante la genesi dei provvedimenti razziali.
A differenza degli altri razzismi del suo tempo, quello fascista è solo tangente alle politiche eugenetiche condotte dal regime, che erano fondamentalmente razziste nella Germania nazista e invece assenti nei razzismi coloniali e post-schiavisti rispettivamente britannico e statunitense. Infatti sebbene i provvedimenti per la difesa della razza prevedessero l'apartheid degli ebrei e dei non-indoeuropei rispetto agli italiani ariani, tutte le provvigioni e le iniziative a carattere eugenetico (ginnastica, colonie per l'infanzia, sanatori, Opera Maternità e Infanzia etc.) proposte e imposte dal regime continuarono ad applicarsi anche ai sudditi di cittadinanza libica e a quelli dell'AOI, almeno fino al 1942.[104]
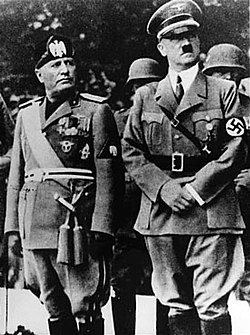
Il nazionalsocialismo si presenta, soprattutto dal punto di vista ideologico, come una particolare forma di "socialismo fascista". Nei fatti tuttavia l'aspetto "socialista" del regime tedesco era fondamentalmente una trovata propagandistica. L'interpretazione più diffusa è che il nazismo fu anch'esso una forma di fascismo; il regime tedesco si ispirava apertamente a Mussolini e condivideva col fascismo italiano impostazione economica, politica e sociale, nonché la politica estera aggressiva e i tratti ideologici caratteristici del fascismo fattosi regime.
Questa visione è respinta da alcuni storici che vedono nelle dittature italiana e tedesca due fenomeni distinti. Stanis Ruinas per esempio sostiene che il nazismo nasce come ideologia gemella al fascismo italiano, e tale rimane solo fino al 29-30 giugno 1934, quando con la "notte dei lunghi coltelli" la corrente "di destra" facente capo a Hitler elimina la corrente "di sinistra" facente capo a Ernst Röhm. Da quel momento il nazismo abbraccia implicitamente il capitalismo e si prefigura come un'ideologia prettamente di destra, abbandonando ogni ipotesi rivoluzionaria e quindi rimanendo "socialista" solo nel nome.
Secondo Ruinas da quel momento il paragone tra fascismo e nazismo è quindi unicamente fittizio e artificialmente mantenuto dal nazismo per motivi propagandistici di immagine pubblica. Questa analisi si basa sull'osservazione che nel fascismo italiano la componente "di sinistra" continuò a esistere, sebbene piuttosto emarginata per molti anni, e anzi nella RSI sarebbe tornata maggioritaria.[105]
Secondo altre analisi, tuttavia, il passaggio dal cosiddetto "fascismo-movimento" (con slogan talvolta socialisteggianti) al "fascismo-regime" (con tratti più nettamente conservatori) fu un processo analogo, sebbene meno cruento e drastico, a quanto avvenuto in seguito in Germania in forma più convulsa durante la Notte dei lunghi coltelli. La spiegazione sociologica di questa "frattura" in entrambi i fascismi è dovuta al ruolo particolare (e caratterizzante del fascismo rispetto a generiche dittature di destra) che ha la mobilitazione dei ceti medi, rovinati dalla crisi economica in Germania o frustrati dalla fine della guerra e dallo scoppio delle lotte sociali in Italia; la mobilitazione di questi gruppi sociali è resa possibile specialmente dalla fraseologia rivoluzionaria e movimentista propria tanto dello squadrismo quanto delle SA, ma diventa successivamente un ostacolo al consolidamento della dittatura e richiede quindi l'eliminazione o l'emarginazione di quell'ala in un momento successivo. Con la RSI la necessità di mobilitare nuovamente ampie masse nella guerra civile spinse Mussolini a recuperare elementi dello squadrismo delle origini che erano stati messi in ombra negli anni precedenti.
Il continuo ritorno a un'idea di romanità portò come logica conseguenza l'affermarsi di teorie filosofiche neo-ghibelline, ossia propugnanti la ricostituzione di un Sacro Romano Impero o di un Impero romano che si ricongiungesse in qualche misura con una mistica tradizione ancestrale, e alla fine proponesse il superamento del fascismo in una forma di nuovo imperialismo spirituale e supernazionale, a carattere essenzialmente anticristiano.
Alfiere di queste tesi fu Julius Evola, filosofo perennialista e vicino in seguito al neopaganesimo romano di certi ambienti neofascisti del secondo dopoguerra, il quale rimase tuttavia alquanto isolato nell'ambito del dibattito culturale e filosofico del regime fascista, dominato invece da logiche nazionaliste e da forti correnti cattoliche che poco spazio intendevano lasciare al cosiddetto imperialismo pagano propugnato dal filosofo. Questa idea trovò in seguito sponda e nuovi argomenti in alcuni ambienti nazionalsocialisti e si diffuse soprattutto nel dopoguerra fra i movimenti neofascisti, neonazisti esoterici e tradizionalisti, restando perlopiù fuori anche dall'estrema destra maggioritaria che sarà rappresentata dal Movimento Sociale Italiano.
Secondo la teoria di Julius Evola, il fascismo si configurerebbe come una delle tante manifestazioni storiche del concetto più ampio di Tradizione, ossia di una società basata sui valori di gerarchia, militarismo e misticismo. In quest'ottica diverrebbero forme di Fascismo in senso lato le più disparate esperienze storiche: da Sparta e Roma alle società celtiche, nordiche e germaniche, al Sacro Romano Impero[106].

L'uomo rurale venne esaltato come l'ideale forma di mascolinità da parte del governo fascista. È tradizionale, ed è anti-moderno. Ardengo Soffici descrive tale ideale mascolinità evidente nelle zone rurali d'Italia:
In antitesi alla borghesia, questa figura è stata iconica nella suggestione che il governo fascista indica come il suo modo di essere, quando nella società del primo Novecento cominciò a venir meno il culto della mascolinità. È importante ricordare che il ruralismo fascista richiede esplicitamente il ripristino di un tradizionale, pre-moderno e rigidamente gerarchico ordine morale. In altre parole, il regime fascista ha utilizzato la figura del ruralismo come un mezzo attraverso il quale ha tentato di trasformare il modernismo in tradizionalismo. A questo proposito, la gioventù contadina che ha cercato di lasciare il villaggio e trasferirsi in città è stata dipinta come fatta di individui mettenti il destino della nazione a rischio attraverso il loro comportamento:
Il modernismo, un fenomeno che include il trasferimento di giovani dai villaggi verso le città, è visto in luce negativa dal governo fascista, perché crea un sotto-tipo di mascolinità italiana che è più abile nel vivere all'interno di un'area metropolitana, assumendo meno responsabilità verso la collettività. In altre parole, la gioventù italiana non è più attiva nel coltivare i terreni agricoli, ma, invece, si disinteressa della collettività e quindi di se stessa, rendendo l'intero paese italiano meno fertile. Metaforicamente, ciò significa che essi smettendo di coltivare la loro mascolinità egemonica globalmente, e fisicamente, smettono di contribuire allo stato, perché quelli che si muovono in città di solito hanno meno figli e si sposano con una frequenza minore. Inoltre, l'ambiente sicuro della metropoli impedisce al "nuovo italiano" di godere il suo contatto con la natura, e gli ha impedito di contemplare profondamente sulle sfide morali, nessuna delle quali è messa a sua prova, come un risultato dell'artificiale, "materialista" atmosfera metropolitana che è priva di pericoli e avversità.
Il profilo delle personalità del fascismo rifondato nel Partito Fascista Repubblicano al Congresso di Verona si distinse da quello del ventennio per il protagonismo di numerosi personaggi degli ambienti squadristi, via via emarginati da Mussolini dopo la Marcia su Roma. I vecchi squadristi, che per lunghi anni spesso erano stati relegati a incarichi di secondo piano, tornarono alla ribalta, prendendo l'iniziativa sin dall'annuncio dell'armistizio e prima della proclamazione della Repubblica Sociale Italiana il 27 settembre 1943.
Un'altra caratteristica del fascismo repubblicano fu l'importanza assunta dalle componenti volontarie, che si vennero coagulando sin da prima della fondazione della repubblica e poi ne costituirono un tratto significativo[109], nelle proprie formazioni sia militari sia civili. Questo sforzo si lega al recupero della tradizione "movimentista" del primo fascismo. Ciò nonostante la RSI dovette ricorrere a numerosi bandi di leva al fine di mobilitare alcune centinaia di migliaia di italiani. Solo con la reiterazione dei bandi - che includevano la minaccia di passare per le armi i renitenti - si riuscì in fasi successive e ad arruolare un numero complessivamente calcolato da fonti reducistiche in sette-ottocentomila uomini[110], dei quali, sempre secondo le stesse fonti fasciste, un numero oscillante attorno ai duecentomila volontari[111], in buona parte giovanissimi (anche minorenni). La maggioranza della popolazione mantenne un atteggiamento di indifferenza e freddezza (la cosiddetta "zona grigia"[112]) o di ostilità (la "Resistenza disarmata" nelle fabbriche con centinaia di migliaia di scioperanti e sabotaggi continui dello sforzo bellico, nelle campagne, nei campi di internamento tedeschi (col rifiuto degli italiani internati di aderire alle forze armate della RSI[113]) verso il rinato fascismo, consentendo al contempo lo sviluppo e il sostentamento della lotta armata antifascista.
Nel corso dei 600 giorni di durata della Repubblica Sociale, a partire dalla Carta di Verona, i dibattiti interni al Fascismo si orientarono essenzialmente su:
Fra le componenti psicologiche e politiche che mossero la RSI e il Fascismo Repubblicano se ne possono evidenziare alcune come emergono dalla memorialistica:
Nell'ambito storiografico italiano il termine "fascismo" è usato soprattutto in riferimento al regime di governo e all'ideologia promossi e attuati da Benito Mussolini tra il 23 marzo 1919 e il 28 aprile 1945. Tale posizione è sostenuta anche da numerosi storici di formazione non-angloamericana.
Alcuni storici ritengono improprio l'utilizzo del termine "fascista" in riferimento alla Germania nazionalsocialista e ai regimi autoritari formatisi in Europa negli anni trenta e quaranta, considerati derivazioni del caso nazista più che di quello fascista (se si eccettuano il Portogallo di António de Oliveira Salazar, la Grecia di Ioannis Metaxas e il cosiddetto Austrofascismo, che tuttavia presentano somiglianze più che altro superficiali col fascismo italiano) o casi a sé stanti (come per la Spagna di Francisco Franco, il cui movimento e regime sono definiti Franchismo per distinguerli da fascismo e nazismo).
In tal senso, anche il termine "nazifascismo" è considerato scorretto da chi sostiene la specificità del fascismo italiano, perché non consentirebbe di cogliere le differenze avutesi tra i due movimenti. Questi studiosi contestano l'utilizzo del medesimo termine in riferimento a regimi autoritari post-bellici, uso che peraltro risulta essere effettuato in modo incoerente e, talora, con funzione di mero insulto (il termine "fascista" è usato, in tale accezione impropria, col significato astoriografico di "inumano, crudele, oppressivo"): in tal modo "fascista" è stato utilizzato tanto per indicare spregiativamente regimi quali quello di Augusto Pinochet in Cile (privo di una reale base ideologica), nonché regimi di segno ideologico opposto (quali quello comunista cinese e russo) oppure la democrazia americana.
A sinistra, il termine "fascista" è talvolta usato per indicare qualsiasi regime autoritario di destra, specie quelli alleati dell'Asse durante la seconda guerra mondiale, come il regime militarista giapponese o il franchismo spagnolo, o più spesso i loro seguaci. Per alcuni anni, Stalin e la III Internazionale definirono i socialdemocratici come "socialfascisti" (una posizione abbandonata nel 1935).
Dal punto di vista di molte scuole interpretative marxiste, tuttavia, il fascismo vero e proprio è quello dell'Italia e della Germania: un "regime reazionario di massa" secondo la definizione di Palmiro Togliatti, accettata anche dal trotskismo internazionale e in qualche modo vicina alla definizione gramsciana di "rivoluzione passiva". In questo senso, non vengono fatte distinzioni di rilievo fra il regime hitleriano e quello di Mussolini, che vengono invece fatte rispetto a dittature prive di una base di mobilitazione di massa (come quella portoghese di Salazar o quella cilena di Pinochet). Il caso spagnolo è ambiguo, perché se pure esisteva un forte movimento fascista dal lato franchista, Franco non ne faceva parte e anzi si adoperò affinché venissero "riassorbite" in un generico "movimento nazionale" le forze che più apertamente si ispiravano a Hitler o a Mussolini (come la falange spagnola).
All'interno della vasta critica storica sul fascismo, è possibile individuare varie interpretazioni, tra le quali:
Il fascismo definiva sé stesso un sistema politico "totalitario". Nella concezione fascista dello Stato, l'individuo ha libertà e gode di diritti solo quando è pienamente inserito all'interno del corpo sociale gerarchicamente ordinato dello Stato (il cosiddetto Stato etico).
Nelle successive analisi degli storici (a partire dallo studio di Hannah Arendt del 1951) si sono sviluppate sostanzialmente due linee interpretative riguardo al carattere del regime fascista: una promossa inizialmente da Hannah Arendt e sviluppata successivamente da diversi autori, fra cui Renzo De Felice, che lo considera come prettamente "autoritario", e uno che lo considera "totalitario" (ma senza alcun'accezione apprezzativa) e che ha nell'allievo di De Felice Emilio Gentile uno dei massimi sostenitori. Tale interpretazione è soprattutto da riferirsi al concetto, promosso da Emilio Gentile, di:
E ancora:
Inoltre questo totalitarismo è definito da alcuni autori un "totalitarismo statalista"[121] perché, secondo le parole di Giovanni Gentile "per il fascista tutto è nello Stato e nulla [...] ha valore fuori dallo Stato"[122].
Tale interpretazione si basa in gran parte sull'idea, proposta da Hannah Arendt, di considerare il terrore come "la vera essenza" della forma totalitaria di governo; in tal senso, il regime fascista non può considerarsi "prettamente" totalitario in quanto mancò, a differenza di altri regimi quale quello nazista e quello stalinista, uno "sterminio di massa" e un uso costante del "terrore di massa" (cosa che peraltro veniva perpetrata tramite il meccanismo di azione detto Squadrismo).
Mancò inoltre, un completo controllo della comunicazione e dell'informazione[123].
Inoltre, sempre secondo questa interpretazione, lo stato autoritario ha limiti prevedibili all'esercizio del potere, ossia è possibile "vivere tranquilli" e non incorrere nella vendetta dello Stato se si seguono alcune regole di comportamento, e non si fa opera di militanza e propaganda politica[124], mentre nello stato totalitario i limiti all'esercizio del potere sono mal definiti e incerti.
Infine a sostegno di questa tesi vi è anche il fatto che il fascismo (a differenza di nazismo e comunismo sovietico) fu obbligato a convivere (spesso anche trovando un comune accordo[125]) con i poteri della Monarchia e della Santa Sede, i quali, nonostante una progressiva erosione delle proprie prerogative, mantennero la propria autonomia (spesso più formale che sostanziale).[126]
Posizione intermedia fra le due precedentemente citate, il concetto di "totalitarismo imperfetto", coniato dallo storico Giovanni Sabbatucci, riconosce nel fascismo una chiara matrice e una volontà totalitaria, resa però inane dalla presenza di altri poteri (Chiesa e Monarchia), dal suo eccessivo gradualismo e dalla politica mussoliniana di lasciare sempre qualche "valvola di sfogo" a personaggi afascisti o fascisti non "ortodossi" (come ad es. il caso di Nicola Bombacci).[127]
Sono assenti o solo embrionali nel totalitarismo fascista i seguenti attributi caratteristici del caso nazista:
Mentre rispetto alla dittatura sovietica vi è una sostanziale differenza in termini di estensione ed efficacia della repressione del dissenso.
Attributi del totalitarismo fascista:
Nonostante il divieto di ricostituzione del disciolto Partito Nazionale Fascista, stabilito dalla Costituzione Repubblicana (XII Disposizione Transitoria), movimenti fascisti sopravvissero anche dopo la guerra. In particolare il Movimento Sociale Italiano di Pino Romualdi e Giorgio Almirante, che fu accusato a più riprese di ricostituzione del disciolto partito fascista. Il senatore Giorgio Pisanò nel 1989 fonda e guida la corrente interna al MSI denominata Fascismo e Libertà.[130] Nel luglio 1991 Fascismo e Libertà esce dal partito guidato da Gianfranco Fini.[130] Giorgio Pisanò guida la frangia dei camerati irriducibili verso un nuovo progetto politico profondamente mussoliniano; così fonda e diviene Segretario Nazionale del Movimento Fascismo e Libertà (MFL). Successivamente, l'11 dicembre 1993 il Comitato Centrale "missino" approverà il nuovo Movimento Sociale Italiano-Alleanza Nazionale con l'astensione di 10 dirigenti legati all'ex-segretario e combattente della RSI Pino Rauti. Nel 1994 Movimento Sociale Italiano-Alleanza Nazionale sciolse i legami interni con gli esponenti del MSI più nostalgici, trasformandosi in Alleanza Nazionale (AN) durante il congresso di Fiuggi. Fu il momento nel quale il gruppo di dirigenti vicini a Pino Rauti, si staccò da AN, coadiuvando insieme ai membri del MFL di Giorgio Pisanò nel progetto di conservazione dello storico partito, fondando la Fiamma Tricolore quale nuovo soggetto politico. Alcuni mesi più tardi il leader e segretario del MFL lascia però la vita politica, complice l'aggravarsi del suo stato di salute che lo porterà alla scomparsa (17 ottobre 1997). Il Movimento Fascismo e Libertà minoritario all'interno del nuovo soggetto, non trovando spazio ne esce dopo una breve esperienza. Nel 2001 il MFL subisce la scissione di alcuni dirigenti che fondano Nuovo Ordine Nazionale. Relativamente di recente, il 7 maggio del 2004, Pino Rauti il promotore e fondatore della Fiamma Tricolore, dopo alcune vicende personali, ha lasciato anche questo movimento per fondare il Movimento Idea Sociale (MIS).
Nel 2009 il MFL distingue e difende le sue finalità ideologiche nelle posizioni più socialiste dell'originario fascismo rivoluzionario e della Repubblica Sociale Italiana, optando per una netta contrapposizione e rottura verso tutte le altre forze neofasciste che si riconoscono nella destra italiana e/o comunque riconducibili alla cosiddetta Area, denominandosi Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale[131][132].
Contemporaneamente Alessandra Mussolini, nipote del dittatore, lasciava AN in polemica col suo presidente Gianfranco Fini, che aveva preso le distanze dalle posizioni legate al fascismo e alla figura di Mussolini[133]. La Mussolini fondò così un proprio partito (AS, Azione Sociale) che promosse l'alleanza denominata Alternativa Sociale che univa AS ad altri due movimenti neofascisti e nazionalisti: Forza Nuova, guidato da Roberto Fiore, e Fronte Sociale Nazionale, fondato da Adriano Tilgher.
Pagina 1 di 2